Non è intercettazione la fonoregistrazione di una conversazione da parte di uno dei due interlocutori
La registrazione fonografica di un colloquio ad opera di un soggetto che ne sia partecipe costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico della quale l’autore può disporre anche a fini di prova nel processo secondo le disposizioni in tema di prova documentale (Cassazione penale, sentenza n. 10079/2024 - testo in calce).
Il fatto
La vicenda che fa da sfondo alla pronuncia in esame si era conclusa con la condanna dell’imputato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minore, commessi nei confronti delle due nipoti minorenni in un arco temporale di circa cinque anni. La Corte di appello, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado in riferimento all’accertamento della responsabilità dell’imputato, rideterminando la pena in anni 6 e mesi 2 di reclusione; aveva applicato la pena accessoria dell’interdizione legale; aveva sostituito la pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici con quella dell’interdizione perpetua.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento alla luce di plurimi motivi. Per quel che maggiormente interessa la difesa lamentava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 228, 267, 268, 350 c.p.p.), per avere la Corte d’appello ritenuto riscontrate le dichiarazioni delle persone offese, poste a fondamento dell’accertamento della responsabilità del ricorrente, in base ad elementi inutilizzabili, ovvero: a) le dichiarazioni telefoniche di ammissione del fatto rese, durante la fase delle indagini preliminari, dal ricorrente alla madre delle minori, in vivavoce di fronte ai carabinieri con lei presenti, acquisite in atti senza le garanzie previste dagli artt. 267 e 268 c.p.p. in materia di intercettazioni; né utilizzabili come dichiarazioni rese alla polizia di giudiziaria, per l’assenza del difensore; b) le dichiarazioni rese in sede peritale, utilizzate nel rito abbreviato per fini diversi da quelli dell’accertamento peritale e rese, inoltre, al di fuori del setting della seduta, in violazione delle regole stabilite dall’art. 228 c.p.p., riferibili anche al giudizio abbreviato. In particolare si sosteneva l’erroneità della conclusione della Corte di merito nella parte in cui affermava che l’inutilizzabilità non modificava il quadro probatorio di riferimento, sul rilievo che tali dichiarazioni fossero state prese in considerazione sia nel rafforzamento del convincimento della responsabilità penale sia ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
 Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale. Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.Scarica gratuitamente un numero omaggio |
La sentenza
La pronuncia è di sicuro interesse in merito alle argomentazioni spese dalla Corte di cassazione sulla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato nel corso del colloquio telefonico con la figlia e in sede di espletamento dell’incarico peritale.
Preliminarmente la Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo di impugnazione ricordando come per giurisprudenza consolidata sia onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato: il motivo di impugnazione deve cioè illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ritenuto inutilizzabile ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso di specie, l’imputato non avrebbe assolto a tale onere, mentre la sentenza impugnata avrebbe chiarito la non decisività delle dichiarazioni confessorie, a fronte di un quadro probatorio già cristallizzato dalla deposizione delle vittime e dal video dei palpeggiamenti ripreso dal fratello di queste.
Oltre a decretarne l’inammissibilità, la Corte ha dichiarato l’infondatezza del motivo proposto, in quanto ha escluso l’inutilizzabilità della prova per violazione della disciplina delle intercettazioni sull’assunto secondo cui la fonoregistrazione di una conversazione tra due interlocutori da parte di uno di essi non costituisca intercettazione: le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. c.p.p. consistono, infatti, nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato; la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo le disposizioni in materia di prova documentale, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.
Tale distinzione è recepita dall’orientamento prevalente e maggioritario in giurisprudenza e trova la sua origine nella famosa sentenza Torcasio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465 - 01) le quali chiarirono che l’ammissibilità della prova documentale, rappresentata dalla registrazione fonografica di una comunicazione tra presenti ad opera di uno degli interlocutori o di persona ammessa ad assistervi (che non può essere ricondotta alla nozione di intercettazione contenuta nel codice di rito, nella misura in cui difettano “la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la ‘terzietà’ del captante”, poichè “con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori”) implica di regola l’utilizzabilità processuale del contenuto della prova così raccolta, fatta eccezione per le ipotesi in cui mediante tale prova vengano superati divieti espressamente previsti dalla legge e, in particolare, quelli destinati a limitare l’acquisizione di contributi dichiarativi ad opera della polizia giudiziaria con modalità non consentite (la decisione richiamava i divieti fissati dagli articoli 62, 63, 141 bis, 195 e 203 c.p.p.)
Orbene, nel caso all’esame della Sezione assegnataria del ricorso la conversazione fra la madre delle minori e l’imputato era intervenuta con il vivavoce in presenza della polizia di tal che i giudici hanno ritenuto di dar seguito al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata e ribadito da ultimo con riferimento alla trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite un’applicazione specifica: principio, secondo cui tale attività costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Sez. II, n. 26766 del 06/07/2020, Rv. 279653).
Quanto alle dichiarazioni rese a margine delle attività peritali la Corte territoriale ne aveva già dichiarato l’inutilizzabilità per cui la Corte di cassazione si è limitata per esse a rilevare l’inammissibilità del motivo.
Valutata la complessiva inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili.
>> Leggi anche:
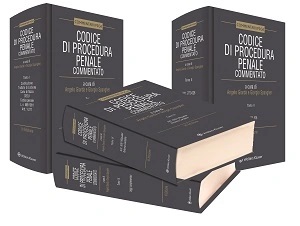 Codice di procedura penale commentato, cura di Giarda Angelo, Spangher Giorgio, Ed. IPSOA. L'opera fornisce, in 4 tomi e oltre 15.000 pagine, il commento degli articoli del Codice di procedura penale e delle principali leggi complementari. Codice di procedura penale commentato, cura di Giarda Angelo, Spangher Giorgio, Ed. IPSOA. L'opera fornisce, in 4 tomi e oltre 15.000 pagine, il commento degli articoli del Codice di procedura penale e delle principali leggi complementari.Consulta gratuitamente l'indice |










