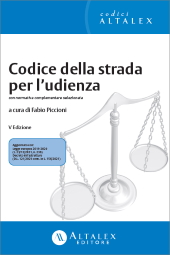Alcoltest
Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge (art. 186 Codice della Strada).

Alcoltest
{prodotti_altalexpedia}
1. Caratteri generali. La nozione di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante
L’art. 186 CdS, rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, stabilisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, prevedendo, al co. 2, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 della Legge n. 120/2012, alcune sanzioni amministrative o ammende in capo a colui il quale guidi in tale stato, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
La norma parla di “ebbrezza” locuzione che, sovente, viene accostata e confusa con quella di “ubriachezza”. In realtà i due termini esprimono realtà differenti: per ebbrezza dobbiamo intendere l’annebbiamento delle facoltà mentali provocato da una eccessiva quantità di alcolici e che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento; l’ubriachezza consiste, invece, nella temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool e si manifesta con il difetto della capacità di coscienza e spesso in forma molesta.
Tale differenza, quindi, risiede nella differente intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nell’ubriachezza a causa della presenza di un maggiore tasso alcolico, tant’è che questa costituisce uno stato avanzato dell’ebbrezza. Si consideri, inoltre, che, mentre l’ubriachezza è punibile solo quando è manifesta, molto spesso l’ebbrezza può non essere manifesta.
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha previsto delle sanzioni graduate a seconda del tasso alcolemico accertato, con la conseguenza che ad un tasso alcolemico inferiore corrisponde una sanzione meno grave rispetto a quella contemplata per un tasso alcolemico più elevato. Gli importi delle sanzioni sono stati recentemente modificati dall'art. 1, co. 1, D.M. 20 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
Attualmente, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, si precedono tre distinte situazioni:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
E’ dibattuta la questione se la nuova disciplina contempli tre autonome ipotesi di reato ovvero un solo reato, di cui alla lettera a) dell’art. 186 CdS, aggravato dalle lettere b) e c) della medesima disposizione.
Come risaputo, le circostanze sono elementi accessori o accidentali che si pongono al margine della fattispecie, andando ad incidere sul trattamento sanzionatorio, determinando a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione di quest’ultimo; sono elementi specializzanti che si caratterizzano come dati che si aggiungono alla fattispecie base, con la conseguenza che tra questa e la fattispecie circostanziale si pone un rapporto di genere a specie.
Venendo alla tematica che a noi interessa, è facile notare come il Legislatore, secondo un primo orientamento, sia intervenuto unicamente sulla misura della pena, graduata in maniera progressiva sulla base del riscontro derivante dall’accertamento quantitativo del tasso alcolemico, con la conseguenza che si tratterebbe di un’unica fattispecie di reato circostanziato, nei confronti della quale è possibile il c.d. giudizio di bilanciamento, ai sensi dell’art. 69 c.p.
La teoria ora esposta è stata oggetto di critica da parte della dottrina più recente in quanto idonea a aumentare la discrezionalità del giudice e contrastante con la volontà del Legislatore diretta a porre in essere un irrigidimento della risposta sanzionatoria.
Le osservazioni di cui sopra sono state accolte dall’impostazione attualmente dominante, secondo la quale, il fatto che le tre ipotesi si distinguano tra loro a seconda del tasso alcolemico accertato alla stregua delle tre distinte fasce, rende evidente che le disposizioni più gravi non contengono tutti gli elementi dell’ipotesi base, oltre ulteriori elementi di specificazione tali da far ritenere più grave il fatto, come accade nelle circostanze aggravanti, ma le tre fattispecie si rapportano secondo uno schema di alternatività reciproca, nel senso che integrata un’ipotesi si escludono, per ciò stesso, tutte le altre.
Dobbiamo ritenere, quindi, nonostante i dubbi prospettati in passato, che si tratti di autonome fattispecie e non di reato circostanziato, come confermato dal giudice nomofilattico: “Con le modificazioni anzidette sono state dunque introdotte tre fasce contravvenzionali che […] integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni: le ipotesi ivi contemplate […] sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi, da un rapporto di incompatibilità” (Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 7305; Cass, pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 28547).
Da ciò deriva che la verifica del tasso alcolemico rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo del reato, sebbene non siano mancate autorevoli voci di segno contrario, dirette a ritenere che la verifica del tasso alcolemico debba essere ricondotta all’interno delle condizioni obiettive di punibilità.
Trattasi di reato comune, il quale può essere commesso da chiunque, a prescindere dalla particolare qualifica soggettiva posseduta, a differenza della fattispecie di cui all’art. 186-bis CdS, il quale può essere commesso solo da chi si trovi in una delle condizioni espressamente contemplate dalla norma, per la sussistenza del quale è necessario, in primo luogo, che il soggetto si ponga alla guida di un “veicolo”, la cui nozione è contenuta, espressamente, all’interno dell’art. 146 CdS.
In tal senso, sono definiti veicoli tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolino sulle strade, guidate da un uomo, ad eccezione:
a) delle macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Come avremo modo di vedere nel corso della trattazione, sono espressamente ricompresi nella nozione di veicoli anche i velocipedi, nonché le macchine operatrici.
Anche il soggetto passivo non risulta essere specificato, se si considera che il bene giuridico oggetto dell’aggressione è la sicurezza della circolazione e l’incolumità degli utenti della strada, appartenente ad una cerchia indeterminata di individui.
2. L'accertamento dello stato di ebbrezza
Il Codice della strada dedica particolare attenzione, ai co. 3 e 4 dell’art. 186, in tema di guida in stato di ebbrezza, agli accertamenti qualitativi diretti alla verifica della presenza di alcool nel sangue, a prescindere da evidenti indici sintomatici.
Il co. 3, in particolare, consente agli organi di Polizia Stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche mediante l’utilizzo di apparecchi portatili, sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza alcun pregiudizio per l’integrità fisica del soggetto sottoposto.
Si tratta dei c.d. accertamenti preliminari, i quali possono essere esercitati direttamente nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, introdotti con il D.L. n. 151/2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2003, e attualmente disciplinati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/a/1/421757/109/42 (Articoli 186 e 187 del codice della strada come modificati dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. Direttive circa l’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).
A campione, quindi, tutti i conducenti possono essere sottoposti agli accertamenti preliminari indipendentemente dal fatto che manifestino i sintomi dell’abuso di alcool, sempre che sia rispettata la riservatezza personale e l’integrità psicofisica del sottoposto.
Precisato che deve trattarsi di accertamento non invasivo, questo non potrà consistere, in alcun modo, in prelievo ematico o altro esame clinico, anche se svolto da personale medico qualificato, posto che, in siffatta ipotesi, si rientra nell’ambito di applicazione del co. 4 dell’art. 186 CdS.
Come ha evidenziato anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, gli “apparecchi portatili”, di cui al co. 3, non si identificano con gli “strumenti e procedure determinati dal regolamento”, di cui al co. 4; mentre il co. 3 prevede una mera facoltà per gli organi di Polizia Stradale, di procedere agli accertamenti preliminari qualitativi non invasivi, il co. successivo prevede la possibilità di procedere agli accertamenti più invasivi non solo nel caso in cui gli accertamenti di cui al co. 3 abbiano dato esito positivo, ma anche direttamente, in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse in stato di alterazione psicofisica.
La normativa, quindi, ha lo scopo di fornire agli operatori dei veloci strumenti di screening al fine di incrementare significativamente il numero dei soggetti controllati, consentendo agli organi di Polizia stradale di richiedere ai conducenti fermati di sottoporsi a tale tipologia di accertamento preliminare anche se costoro non manifestino i tipici sintomi dell’abuso di alcool.
Com’è ovvio, il conducente è obbligato a sottoporsi agli accertamenti preliminari e, nel caso di un suo rifiuto, si applicheranno nei suoi confronti le sanzioni di cui al co. 2 dell’art. 186 CdS, comprese le sanzioni amministrative accessorie, come vedremo in seguito.
Recente giurisprudenza ha stabilito che non si configura il reato di guida in stato di ebbrezza qualora l'alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento (Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2019, n. 39725).
Secondo gli ermellini, le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211).
La giurisprudenza ha precisato anche che il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., la presenza di altri elementi indiziari (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298).
Ne deriva che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
su ShopWki è disponibile:
eBook - Codice della strada per l'udienza di Piccioni Fabio, 2022, Altalex Editore3. Il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
Alla tematica del rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è dedicato il co. 7 dell’art. 186 CdS, prevedendo, per tale eventualità, l’applicazione delle sanzioni di cui al co. 2, lett. c), della medesima norma.
Secondo quanto disposto dalla disciplina contemplata dal D.L. n. 117/2007, nel caso in cui il conducente si fosse rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, doveva essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro, somma che diventava da 3.000 a 12.000 euro se la violazione veniva commessa in occasione di un incidente stradale nel quale fosse rimasto coinvolto il conducente, integrando un mero illecito amministrativo.
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, reintrodotto a seguito del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008, stabilisce che chi, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi, ovvero al controllo con l’etilometro, è soggetto alla stessa pena prevista per chi guidi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La fattispecie, dunque, è integrata anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale a mezzo degli strumenti portatili di cui al co. 3 della suddetta disposizione normativa (Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 11845).
Il co. 7 dell’art. 186 CdS, modificato in sede di conversione del D.L. n. 92/2008, prevede che alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare il tasso alcolemico del conducente consegua anche la confisca del veicolo del condannato.
Dobbiamo ritenere, in maniera conforme al dominante orientamento, che l’ammissione, da parte del conducente, di trovarsi nello stato di ebbrezza non possa in alcun modo rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale del tasso alcolemico (Cass. pen., Sez. IV, 18 settembre 2006, n. 36566).
Secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste concorso materiale tra l’ipotesi in commento e la fattispecie di guida in stato di ebbrezza, in quanto diversa è la ratio dei due precetti, se si considera che la fattispecie di cui al co. 7 dell’art. 186 CdS ha l’ulteriore intento di impedire il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale (Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 1997, n. 6355).
Di conseguenza, ci troviamo in presenza non di un’unica violazione, ma di una duplice violazione commessa mediante condotte ontologicamente diverse e successive dal punto di vista temporale, oltre che lesive di beni giuridici differenti.
Accorta dottrina rileva, inoltre, come nell’ipotesi di condanna per i reati di cui ai co. 2 e 7 dell’art. 186 CdS, la fattispecie contemplata dal co. 7 sarà aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 2, c.p. (l’aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro); una volta commesso il reato di guida in stato di ebbrezza per assicurare a sé l’impunità, viene commesso il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
Diversa dall’ipotesi in commento è quella in cui il conducente sia impossibilitato a sottoporsi agli accertamenti di cui sopra per cause connesse allo stato di ebbrezza o ad altre patologie. In tal caso il soggetto non risponderà del reato di rifiuto per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo, posto che l’incapacità di sottoporsi a tale accertamento ha natura colposa.
Le problematiche sorgono quando il conducente simuli la propria incapacità a sottoporsi alla prova alcolimetrica, mediante artifizi o raggiri.
4. Il buon funzionamento dell'etilometro e la rilevanza dei suoi esiti
Oltre ai test comportamentali, che abbiamo analizzato sommariamente nei paragrafi precedenti, il co. 3 dell’art. 186 CdS autorizza gli organi di Polizia Stradale a sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi, anche mediante l’utilizzo di apparecchi portatili.
Si tratta del c.d. alcoltest di screening o etilometro precursore; il fatto che la legge richieda espressamente che si tratti di accertamenti “non invasivi” lascia supporre che questi vengano effettuati senza alcun pericolo per colui che vi sia sottoposto.
Va preliminarmente evidenziata una prima problematica diretta ad individuare cosa debba intendersi per “accertamenti non invasivi”, data la lacunosità della disposizione di cui al co. 3 accennato, il quale parla della possibilità di utilizzo anche di “strumenti portatili”, ovvero strumenti che richiamano, allo stato della scienza attuale, l’etilometro.
Secondo un primo orientamento, l’uso dell’alcoltest dovrebbe essere ricondotto nella categoria degli “accertamenti successivi ed alternativi”, contemplati dal successivo co. 4 dell’art. 186 CdS, rappresentando, le indagini qualitative del co. 3, un intervento prodromico, ma non necessario, di verifica dello stato di ebbrezza, fondato su una semplice percezione sensoriale di atteggiamenti o comportamenti che appaiono compatibili con l’assunzione di sostanze alcoliche oltre i limiti.
Gli accertamenti non invasivi, dunque, dovrebbero far riferimento a strumenti portatili diversi dall’etilometro, ovvero test che vengono effettuati dagli operatori di Polizia Stradale mediante apparecchiature idonee a fornire il risultato della positività o meno dello stato di ebbrezza alcolica senza indicare il valore preciso di alcool nel sangue e che, proprio per tale motivo, non necessitano di omologazione.
Nel novero di tali apparecchiature è possibile, ad esempio, far rientrare l’etilometro a torcia, il cui funzionamento è simile a quello dell’etilometro elettronico, il quale utilizza, anche in questo caso, l’aria espirata dal soggetto, ma che, a differenza dell’etilometro a fiala monouso e di quello elettronico, non necessita di boccaglio, non avendo bisogno di alcun contatto fisico con il sottoposto, ed il risultato del test è particolarmente facile da leggere, considerato che l’apparecchio consta di tre led luminosi, verde, giallo e rosso, a seconda del quantitativo di alcol presente nell’aria espirata, che si illuminano dopo che l’individuo ha soffiato nell’apposito cono situato all’estremità dell’apparecchio.
Come ha confermato, recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte, con una pronuncia già citata in precedenza “l’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore di tasso alcolemico nel sangue” (Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 8805).
In conclusione, l’accertamento qualitativo è in grado di fornire solo un risultato in termini di presenza o assenza di una sostanza, con riferimento ad un “valore soglia” (detto anche cut-off), quale elemento per stabilire la negatività o la positività di un dato campione.
Abbiamo avuto modo di vedere come la modifica dell’art. 186, co. 2, CdS, preveda l’introduzione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di incidenti stradali.
É evidente che, al fine di accertare la penale responsabilità del conducente, appaia di particolare importanza l’accertamento effettivo e preciso dello stato di alterazione e, quindi, il valore probatorio dell’etilometro, quale strumento maggiormente impiegato dalle forze dell’ordine per la verifica dell’ab(uso) delle sostanze alcoliche.
A tal proposito, il co. 4 dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada dispone che l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata, precisando che l’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell’aria respirata, detto etilometro, il quale deve rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Salute, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante una stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
Il soggetto è ritenuto in stato di ebbrezza, con una presunzione iuris et de iure, che non ammette prova contraria, quando la concentrazione alcolica rilevata corrisponda ad un valore superiore a 0,5 g/l.
Attualmente esistono due tipologie di etilometro: l’etilometro a fiala monouso e l’etilometro elettronico, se non consideriamo l’etilometro on-line, il quale permette di effettuare un calcolo sulla base di una formula scientifica che si basa sul consumo effettuato nell’arco di un’ora, ed il Phone alcoltest, una utility che può essere installata sul telefono cellulare che permette di effettuare un test di autovalutazione dello stato alcolemico grazie all’inserimento di alcune informazioni, quali l’età, il peso, il genere maschile o femminile dell’assuntore o l’essere a stomaco vuoto o meno.
Con la Circolare del 18 febbraio 2008, il Ministero della Salute ha elencato una serie di requisiti che gli etilometri a fiala monouso debbono possedere per assicurare la non invasività. Innanzitutto, si precisa che “l’etilometro a fiala monouso si configura essere un oggetto la cui funzione principale è quella di dare evidenza colorimetrica della presenza di alcool nell’aria espirata dal soggetto che lo utilizza. Poiché l’evidenza colorometrica è conseguenza di una reazione chimica, la funzione dell’oggetto è determinata principalmente dalla composizione chimica piuttosto che dalla forma dell’oggetto stesso. Ne consegue che l’etilometro a fiala monouso si configura essere un preparato in un contenitore e in quanto tale deve soddisfare le disposizioni - in termini di classificazione, etichettatura ed imballaggio - di cui alla Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recepita nella normativa nazionale con Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65”.
Gli etilometri a fiala monouso si configurano come preparati chimici che debbono rispettare anche le prescrizioni contenute all’interno del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1272 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. Classification, Labeling and Packaging).
La presenza di alcol nell’aria espirata dal soggetto è indicata dalla variazione del colore della sostanza presente nella fiala (bircomato di potassio), con la conseguenza che, più è evidente tale variazione, tanto maggiore sarà il quantitativo di alcool presente nel soggetto sottoposto al test.
L’etilometro elettronico portatile consta in una speciale apparecchiatura che consiste nel soffiare aria all’interno di un boccaglio monouso all’interno del quale è presente un sensore di gas capace di rilevare la presenza di alcool etilico. Il risultato appare su un display elettronico presente sull’apparecchio.
É necessario, comunque, che gli etilometri siano omologati dalla Direzione generale della M.C.T.C. dopo essere stati sottoposti ad una serie di prove da parte del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), necessarie al fine di verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalla legge; verifiche che debbono essere effettuate periodicamente, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero della Salute.
L’etilometro deve non solo essere identificabile, essendo necessario che riporti una targhetta inamovibile con l’indicazione del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi dell’omologazione e del numero di identificazione, ma anche accompagnato da un libretto metrologico e da un manuale di istruzioni in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione.
L’efficacia probatoria dell’alcoltest, nonostante la regolarità delle apparecchiature utilizzate, può incontrare diverse problematiche, derivanti da eventuali altre sostanze in grado di interferire nella rivelazione strumentale dell’alcool. Molte, infatti, sono le sostanze, quali i farmaci o gas presenti all’interno dell’organismo umano, o elementi chimici contenuti in cibi, solventi o prodotti industriali, capaci di interferire su detta misurazione.
Problematica così nota che nell’appendice B del D.M. 196/1990 è riportato un elenco delle sostanze capaci di influire sulla rilevazione dell’alcool, con le relative concentrazioni nei gas di prove ottenuti sia miscelando le stesse con aria sia attraverso il loro gorgogliamento in acqua.
In giurisprudenza, ad esempio, si è ritenuto che la malattia porfiria non influisca sulla correttezza della misurazione del tasso alcolemico. Pertanto, va ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 CdS, il conducente che, fermato alla guida di autovettura, presenti chiara sintomatologia di stato di ebbrezza, alito vinoso ed eccessiva loquacità, nonché risulti positivo all’esame alcoltest (Trib. La Spezia, 11 gennaio 2011, n. 6).
Affinché l’utilizzo di medicinali possa assumere la veste di scriminante è necessario che abbia provocato, in via esclusiva, lo stato di ebbrezza e che al conducente non possa essere mosso alcun rimprovero a titolo di colpa.
Ad esempio, anche se risultasse accertato il nesso di causalità tra l’assunzione della sostanza medicamentosa e lo stato di ebbrezza, il soggetto che ne faccia uso per finalità terapeutiche, che sia a conoscenza degli effetti della sostanza o del particolare contenuto chimico della stessa, dovrebbe esimersi dal mettersi alla guida del veicolo dopo l’assunzione. “La legge non precisa circa la natura delle bevande alcoliche, la cui assunzione sia rilevante, onde il reato, secondo la giurisprudenza, sarebbe ravvisabile anche quando il superamento del tasso alcolemico fosse determinato dall’assunzione di farmaci in soluzione alcolica; né, in tal caso, il reato potrebbe essere escluso in ragione della pretesa finalità terapeutica dell’ingestione dei farmaci, giacché il soggetto, se e in quanto edotto della composizione alcolica del farmaco, avrebbe dovuto, comunque, astenersi dalla guida” (Cass. pen., Sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 38121).
Il co. 2 dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada dispone che il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, in base al quale il soggetto è considerato in stato di ebbrezza, deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Si tratta di uno spazio di tempo minimo, la cui inosservanza da luogo all’illegittimità del risultato della prova.
La ratio della disposizione è quella di evitare l’ottenimento di misurazioni non rispondenti al vero, anche se i cinque minuti previsti dalla normativa potrebbero non sembrare uno spatium temporis sufficiente ad ottenere una prova certa ed affidabile. Come ha precisato la giurisprudenza “A norma dell’art. 379 reg. att. CdS, secondo co., la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Non è possibile, dunque, ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste alle lett. a), b) e c) dell’art. 186 CdS, secondo co., se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei” (Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2009, n. 3346).
Al tempo stesso, però, non sussiste reato se il soggetto sottoposto al test, per un problema di asma clinicamente accertato, non riesca a portare a termine la prova a meno che, il giudice non riesca a desumere lo stato di alterazione psicofisica da altro elemento sintomatico dello stato di ebbrezza, elemento che deve essere univoco, concreto e significativo (Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2012, n. 25399), come avremo modo di approfondire nelle pagine che seguono.
In altra pronuncia si legge: “La disciplina svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito nella procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato, in conseguenza di tale funzione della normativa, nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei” (Cass. pen., Sez. IV, 27 giugno 2012, n. 25399).
Principio che trova conferma anche in altra giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nell’eventualità in cui non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile dell’ipotesi meno grave, oramai depenalizzata per effetto della novella di cui alla l. 29 luglio 2012, n. 120, precisato che, secondo pacifico e consolidato orientamento, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo e, come visto, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale” (Cass. pen., Sez. IV, 14 maggio 2012, n. 18134).
Sta di fatto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esercizio dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito dell’alcoltest, quando tale circostanza sia sfornita di riscontri probatori (Cass. pen., Sez. IV, 30 marzo 2004, n. 45070).
Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza sono rilevanti anche i centesimi di grammo; La modifica del co. 2 dell’art. 186 CdS, con l’indicazione delle tre diverse fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata, infatti, voluta dal Legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravissime conseguenze che ne derivano in termini di incidenti stradali. In tale ottica, pertanto, è contraddittorio che il Legislatore medesimo, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi.
A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che “in quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi […] La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro. In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile” (Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 2010, n. 32055).
Al fine di evitare malfunzionamenti dell’etilometro, si consideri che ciascun apparecchio è dotato di un meccanismo di autodiagnosi, che si avvia ad ogni accensione e al termine di ogni misurazione, in grado di segnalare se nell’ambiente in cui questo opera vi siano residui di alcool nell’aria o altre sostanze in grado di interferire sul sistema di misurazione, anche se, in concreto, tale sistema non potrebbe essere in grado di rilevare misure non accurate che ricadono al di fuori dell’accuratezza dello strumento.
Ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza è sufficiente che i valori rilevati dall’etilometro siano riportati nel verbale di contestazione redatto dalla Polizia giudiziaria operante, a nulla rilevando che gli stessi non risultino leggibili sugli stampati forniti dall’apparecchiatura (Cass. pen., Sez. IV, 26 febbraio 2008, n. 18448).
Un’ultima considerazione appare di indubbia importanza; l’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza viene considerato quale accertamento urgente che gli ufficiali e gli agenti di polizia compiono sulla persona, ai sensi dell’art. 354, co. 3, c.p.p.?
É bene ricordare come la norma stabilisca che se ricorrono i presupposti previsti dal co. 2 della medesima disposizione, ovvero il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel co. 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e i rilievi sulle persone diversi dall’ispezione personale.
Se consideriamo tali accertamenti come “accertamento urgente”, ne deriva che il soggetto debba essere obbligatoriamente avvisato della facoltà di essere assistito dal proprio difensore, sebbene quest’ultimo non abbia il diritto di essere preventivamente avvisato.
A questo proposito ci dobbiamo chiedere quali siano le conseguenze del mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha seguito un percorso evolutivo che ha portato, in un primo momento, a considerare la conseguenza dell’omissione come mera irregolarità (Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2009; Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2007), per poi passare ad aperture verso la nullità, sebbene di carattere relativo (Cass. pen., Sez. IV, 16 settembre 2003, n. 42020), ed infine approdando ad una soluzione diretta a configurare l’omesso avvertimento in termini di nullità generale a carattere intermedio.
A tale ultima soluzione è pervenuta la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “gli agenti accertatori, prima di compiere l’accertamento in questione, hanno l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a norma dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’omesso avviso all’indagato da parte degli agenti che eseguono l’accertamento comporta la nullità dell’atto a regime intermedio che, secondo quanto previsto dal secondo co. dell’art. 182 c.p.c., quando la parte vi assiste, deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento di un successivo atto del provvedimento” (Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 27736).
A favore della sanabilità della nullità della mancata contestazione entro i tempi è l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, sentenza 23 aprile 2010, n. 15638).
Si tenga presente, inoltre, che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore non ricorre quando l’accertamento sia effettuato in via esplorativa, in quanto trattasi di attività di polizia amministrativa, mentre ricorre detto obbligo nel caso in cui gli ufficiali ritengano, al momento dell’accertamento, di poter desumere lo stato di alterazione del soggetto da qualsiasi elemento sintomatico dello stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 12 febbraio 2008, n. 10850).
Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest (Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Al fine di inquadrare le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l'apparecchio dell'etilometro utilizzato dagli agenti accertatori in funzione della configurazione della piena attendibilità della attività di accertamento, occorre fare riferimento alla disciplina risultante dal d.p.r. n. 495 del 1992, art. 379.
In particolare, agli artt. 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che gli etilometri debbono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità ed essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, debbono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ovvero alla c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.
Da tale dettato normativo si evince che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso.
L'affidabilità dell'omologazione e della taratura di tali apparecchi fa sì che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio diretto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista, dando luogo ad una presunzione in danno dello stesso.
Da ciò ne deriva che alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi del codice della strada, la Pubblica Amministrazione è tenuta all'assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcoltest, nonché della attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strad., qualora l'alcoltest risulti positivo, costituiva onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento come, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendosi essa limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio 2015, n. 12265; Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2011, n. 42084).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 29 aprile 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del D.lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, così esonerando gli utilizzatori dall'obbligo di verifica periodica di funzionamento e taratura delle apparecchiature.
Tale principio veniva applicato in caso di etilometro dalla Cassazione civile, secondo cui, in tema di violazione del codice della strada, il verbale di accertamento effettuato mediante etilometro non deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcoltest sia stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla Pubblica Amministrazione poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (Cass. civ., Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Gli ermellini, sulla scia dell'insegnamento della Corte Costituzionale recepito dalla giurisprudenza civile, ha deciso di modificare il tradizionale orientamento, in quanto questo ha comportato il gravoso onere per il privato, sia in sede civile che penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento, senza considerare come la prova del malfunzionamento dell'etilometro appaia particolarmente difficoltosa se si considera che detta apparecchiatura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione. In tema di guida in stato di ebbrezza, quando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 38618). Dal punto di vista strettamente processuale, il principio è conforme a quello di carattere generale secondo cui l'accusa deve provare i fatti costitutivi del reato, mentre spetta all'imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinati situazione, che siano rilevanti per il diritto. L'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.

Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano One LEGALE: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati. |