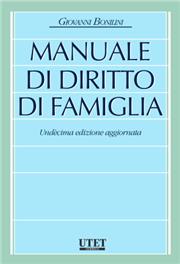Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Con l'espressione "violazione degli obblighi di assistenza familiare" si intendono le fattispecie penalmente sanzionate dagli artt. 570 e 570bis c.p.
In particolare, l'art. 570 punisce:
- chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge;
- chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
L'art. 570bis punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare
di Elena Salemi
1. La violazione degli obblighi di assistenza familiare
1.1. L’art. 570 c.p. e l’evoluzione giuridico-sociale del concetto di “famiglia”
L’art. 570 c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, statuisce che: <<Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale1, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato (per sua colpa).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge>>.
Con tale disposizione il Codice Rocco introduce una novità legislativa rispetto al codice Zanardelli.
All’indomani della sua emanazione, peraltro, la norma fu ben accolta dalla dottrina dell’epoca, la quale individuò nella stessa la volontà del Legislatore di tutelare la famiglia dai sempre più frequenti attacchi, che provenivano dagli atteggiamenti “snaturati” dei cittadini.
Tale lettura era, d’altronde, confortata dai contenuti della relazione del Guardasigilli, ove, per l’appunto, si legge che la norma in esame costituiva il rimedio contro le sempre più frequenti forme <<disgregative dell’unità fisica e morale della famiglia>>2.
La famiglia, infatti, veniva considerata come elemento primario della società e, di conseguenza, la tutela dello Stato doveva necessariamente passare attraverso la tutela della famiglia, la quale era unita materialmente e moralmente sotto l’egida del capo famiglia, sua guida gerarchica3.
Va, altresì, ricordato che, in quel preciso momento storico, dominava incontrastato il principio di autorità del marito all’interno della famiglia e, pertanto, l’art. 570 c.p. venne considerato come una disposizione che, finalmente, avrebbe garantito e mantenuto saldi i legami morali ed economici che per legge riguardano tutti i componenti del nucleo familiare 4.
Fu, addirittura, scritto che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sua complessa struttura, disciplinava le varie funzioni materiali e morali della famiglia, garantendo l’osservanza dei doveri assistenziali, in maniera tale da assicurare lo svolgimento di una vita familiare sana ed ordinata5.
In tal modo, si eliminava << Lo scandalo di coloro che si rendono dolosamente estranei alla loro famiglia di cui per legge naturale, prima ancora che per la legge civile, debbono sentire ed assumere tutta la responsabilità >>6.
Tuttavia, ben presto ci si rese conto che l’art. 570 c.p., se da un lato tendeva a reprimere i comportamenti disgregatori dell’armonia della famiglia, dall’altro metteva in discussione, pregiudicandolo, l’indiscusso accentramento dei poteri nella figura del capo famiglia 7.
Scrive a riguardo un autore << La previsione della sanzione penale evidenziava l’aspetto del dovere nelle potestà familiari: la potestà maritale, la patria potestà, l’amministrazione dei beni dotali, l’amministrazione esclusiva dei beni della comunione, configurati dalla legge civile prevalentemente come un complesso di attribuzioni riconducibili alla posizione di supremazia del marito nell’ambito della famiglia, alla luce dell’art. 570 c.p. venivano a proporsi come altrettanti doveri giuridici>>8.
Dalle superiori considerazioni, appare evidente come il reato in questione costituiva un limite al potere incontrastato del capofamiglia, in quanto ribaltava la posizione di debolezza della moglie, trasformandola in una posizione di forza.
Di tale insidia, ben presto, si resero conto i giuristi dell’epoca, i quali difesero il potere del capofamiglia, circoscrivendo l’applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice.
Le superiori considerazioni certamente appaiono anacronistiche, in quanto frutto di una concezione della famiglia superata da tempo, ma costituiscono una premessa storica importante, ai fini della comprensione di una norma, che ha quasi un secolo di vita.
Invero, fortunatamente, il concetto di “famiglia” si è evoluto rispetto alla concezione del 1930, passando da un ordine verticale ad un ordine sempre più orizzontale9, attraverso una serie di passaggi storico-normativi che via via lo hanno modificato, quali:
- l’introduzione del nuovo codice civile nel 1942;
- l’entrata in vigore della Carta Costituzionale nel 1948;
- la riforma del Diritto di Famiglia nel 1975;
- La riforma ad opera della legge n. 54/2006;
- L’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà).
I vari interventi legislativi, naturalmente, hanno inciso sull’evoluzione dell’interpretazione della norma de qua.
Correttamente, è stato ritenuto che l’interpretazione dell’art. 570 c.p. riflette pienamente l’evoluzione storico-normativa dell’istituto della “famiglia”.
Ciò in quanto, il Legislatore del 1930 ha introdotto una fattispecie incriminatrice insufficientemente determinata e tassativa, tale da consentire al diritto penale di adeguarsi all’evoluzione dei costumi familiari, che si sono succeduti in quasi novant’anni10.
L’intenzione del Legislatore del 1930 era quella di introdurre una fattispecie incriminatrice, avente lo scopo di punire penalmente colui che si sottrae ai doveri di solidarietà, derivanti dall’assunzione del ruolo di genitore o dallo status di coniuge.
E’ importante notare come la norma in questione trovi applicazione in tutti i casi in cui il soggetto attivo del reato sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale, mentre nel caso del patner, il riferimento è fatto esclusivamente al “coniuge”.
Al riguardo va evidenziato, come il D.Lgs. n. 6/201711, abbia introdotto l’art. 574 ter c.p., rubricato “Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale”12, a chiusura del Titolo XI (“Dei delitti contro la famiglia”.
In particolare, la norma statuisce che:
1) “agli effetti della legge penale”, con il termine matrimonio si fa riferimento anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2)) nel caso in cui la qualità di coniuge è ritenuta dalla legge elemento costitutivo del reato o come circostanza aggravante, essa si deve intendere riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
E’ evidente che la disposizione in esame:
-
ha ampliato la nozione penalmente rilevante di ‘matrimonio’, con l’effetto di rendere configurabile in relazione alle ‘unioni civili’ i delitti di bigamia (art. 556 c.p.) e di induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.).
-
Ha esteso la qualità di “coniuge” alla parte dell’unione civile, nel caso in cui tale qualità sia ritenuta dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante.
E questo il caso dell’art. 570 c.p. Pertanto si può affermare che il far venir meno i mezzi di sussistenza al partner unito civilmente, integra gli estremi del reato de quo. Resta, tuttavia, controverso se la norma sia applicabile anche alle convivenze di fatto.
Invero, il dato letterale e l’assenza di qualsivoglia riferimento normativo, sembra escludere tale possibilità.
1.2. Condotta tipica e modalità esecutive del reato
L’art. 570 c.p. prende in considerazione tre diverse condotte delittuose:
1) l’abbandono del domicilio domestico o l’assunzione di altra condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, condotte che determinano la violazione dell’obbligo di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge (art. 570, primo comma).
2) la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge (art. 570, comma secondo, n. 1).
3) la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge (art. 570, comma secondo, n. 2).
Tali condotte, pur essendo autonome tra loro, hanno quale comune denominatore l’esigenza di tutelare l’interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari, sia sotto il profilo economico e fisico, sia dal punto di vista morale.
La dottrina prevalente ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal Legislatore determinano una scissione della norma in due parti: il primo comma, nel quale si prende in considerazione la violazione di doveri quasi prevalentemente morali, ed il secondo comma ove, invece, si tutelano dei valori esclusivamente economici13.
Tale dottrina, peraltro, trova conforto nell’estrema genericità della formula legislativa che dà spazio ad una interpretazione ampia e discrezionale che ha determinato una sovrapposizione tra condotta tipica e modalità esecutive della stessa.
Il problema, che si è posto, prevalentemente, con riferimento al primo comma, può trovare soluzione soltanto rimanendo legati al dato testuale, dal quale appare evidente che la condotta tipica del reato è la sottrazione agli obblighi di assistenza, condotta che può essere realizzata attraverso l’abbandono del domicilio domestico ovvero tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia14.
Orbene, fatta tale necessaria premessa, appare opportuno analizzare siffatte condotte separatamente.
1.2.1. Il primo comma dell’art. 570 c.p.: l’abbandono del domicilio domestico
Tale disposizione, prima della riforma del diritto di famiglia, assumeva risvolti diversi a seconda che l’abbandono del domicilio avvenisse ad opera della moglie o del marito.
Così, ad esempio, si ritenne che l’allontanamento della moglie anche per un breve lasso di tempo aveva conseguenze più gravi per l’ordine della famiglia rispetto all’allontanamento del marito. Ciò in quanto la donna coniugata rivestiva una peculiare posizione morale all’interno della società.
Ed ancora, si reputò che l’allontanamento della donna per motivi di lavoro, anche se giustificato dalla necessità di pagare un proprio debito, integrava il reato in questione, mentre, di contro, appariva del tutto lecita l’eventuale condotta similare del marito
Con l’entrata in vigore della legge n. 151/1975 e la conseguente abrogazione dell’obbligo, incombente sulla donna, di seguire il marito in qualsivoglia luogo egli ritenesse opportuno fissare la propria residenza e di avere il medesimo domicilio del marito, la disposizione de qua ha assunto una diversa effettività.
Ciascun coniuge, infatti, può stabilire il proprio domicilio nella sede dei propri affari o interessi, senza che sia necessario il preventivo assenso dell’altro15 e la residenza familiare deve essere fissata di comune accordo ai sensi dell’art. 144 c.c.16.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che <<la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia>>17.
La riforma legislativa, pertanto, ha determinato un mutamento radicale nel modo di concepire la famiglia18 ed, in siffatto contesto, la coabitazione non è più uno degli aspetti fondamentali della vita coniugale. In tale situazione, l’allontanamento dal domicilio domestico assume rilevanza giuridica solo allorquando l’allontanamento fisico manifesta la volontà di interrompere quell’unione tipica della famiglia19.
In buona sostanza, sussiste la condotta di abbandono del domicilio domestico, nel caso in cui un soggetto, dopo aver costituito il domicilio domestico, lo abbandona illegittimamente, sottraendosi agli obblighi derivanti dalla coabitazione nei confronti del coniuge o di coloro che sono soggetti alla sua potestà.
Sull’argomento, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto la sussistenza del reato, nel caso in cui, dal comportamento del coniuge, emerga la volontà di abbandonare il domicilio domestico in modo improvviso e definitivo, intento desumibile anche dalla condotta immediatamente susseguente.
Ad esempio, ad avviso della Suprema Corte, il reato è integrato qualora la moglie abbia addotto di partire in vacanza (con l’accordo del marito), ma in realtà aveva deciso di interrompere la convivenza20.
In particolare, nel caso oggetto della menzionata decisione, la moglie aveva lasciato una lettera al marito, con cui lo informava che intendeva iniziare una nuova esistenza con un altro uomo, che era l'amico con il quale era partita, e non si era preoccupata per diversi giorni di dare al coniuge notizie né sue, né tanto meno della figlioletta.
Solamente dopo che il marito aveva sporto denuncia, ella aveva fatto ritorno a casa.
Si legge nella motivazione della sentenza de qua: <<E' evidente che, alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente della (moglie) non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sé la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali>>21.
Naturalmente, come sopra evidenziato, l’abbandono del domicilio domestico integra il reato di cui all’art. 570 c.p. esclusivamente nel caso in cui abbia determinato la rottura dell’unione familiare e, di conseguenza, sia avvenuto in assenza di una giusta causa.
La giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza di una giusta causa qualora sussistano <<ragioni di carattere interpersonale tra i coniugi che non consentano la prosecuzione della vita in comune>>22. In siffatte ipotesi, peraltro, il giudice penale si deve limitare a valutare le ragioni dell'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge, imputato del reato, e deve avere presente che la riforma del diritto di famiglia, posta in essere dalla legge n. 151/1975, annovera, tra le cause che non consentono la prosecuzione della vita in comune, tutte quelle che si desumono dai principi, tratti dagli art. 145, 146 e 151 c.c., tra i quali quello della <<intollerabilità della prosecuzione della convivenza>>.
La giusta causa sussiste, altresì, quando il comportamento di un coniuge, non occasionato dalla condotta dell’altro, renda intollerabile la prosecuzione della convivenza23.
Dalle superiori considerazioni, discende che l’abbandono del domicilio domestico successivo alla proposizione della domanda di separazione è privo di ogni rilevanza giuridica.
Invero, è stato ritenuto che la manifestazione di volontà di un solo coniuge di rompere il vincolo matrimoniale, a causa del venir meno di quella unione materiale e spirituale, che caratterizza il matrimonio, sebbene non formalizzata nelle forme di legge, è di per sé sufficiente ad interrompere l’obbligo di coabitazione.
Così, ad esempio, è stata ritenuta sufficiente ad integrare la "giusta causa" di allontanamento dal domicilio domestico, una lettera di addio di un coniuge all’altro, con la quale si fa riferimento ad una situazione di intenso disagio nel rapporto matrimoniale24.
Sull’argomento, è alquanto significativa una sentenza della fine degli anni ottanta, la quale, evidenziando l’avvenuto mutamento della concezione del vincolo coniugale, ha statuito l’importante principio di diritto, secondo cui <<Non è configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p. sulla sola base dell'abbandono del domicilio domestico. Infatti, considerato che la fattispecie prevista all'articolo citato è ravvisabile solo quando la condotta dell'agente – abbandono o comportamento contrario all'ordine o alla morale delle famiglie - si realizzi nella sottrazione agli obblighi di assistenza, occorre però tener conto che, a seguito dell'evoluzione del costume e della nuova normativa che regola i rapporti di famiglia, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile attraverso la volontà, anche di uno solo, di rompere il vincolo matrimoniale. Ne deriva che la manifestazione di tale volontà, pur se non ancora perfezionata nelle forme previste per la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente ad interrompere taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione>>25.
I superiori principi sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12310/2012.
Con la pronuncia in questione è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro con la quale era stata confermata la decisione del Tribunale di Castrovillari, che condannava una moglie, riconoscendola colpevole del reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale (art. 570 co. 1 c.p.).
La donna, infatti, si era allontanata dall’abitazione familiare senza farvi più ritorno, così sottraendosi agli obblighi di assistenza morale nei confronti del marito.
Secondo la Corte di Appello, l’abbandono della casa coniugale da parte dell’imputata era avvenuto in assenza di qualunque ragionevole spiegazione. Conseguentemente, tale condotta doveva necessariamente ricondursi alla deliberata volontà della stessa e non già ad eventuali cause di forza maggiore o a fatti costrittivi subiti dalla donna.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo violazione dell’art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione con riferimento alla mancanza di idonee prove della sussistenza del reato contestato alla sua cliente, segnatamente sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Nel ricorso, infatti, veniva lamentato che, nel corso del procedimento, erano rimaste del tutto ignote le ragioni per cui la donna si era allontanata dalla casa coniugale, non emergendo affatto se tale condotta era stata effettivamente priva di giustificazione.
Inoltre la sentenza d’appello, così come quella di primo grado, aveva basato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni del marito, persona offesa costituitasi parte civile, senza tuttavia fornire indicazioni sui riscontri acquisiti a sostegno dell’assunto accusatorio e senza fornire adeguata risposta ai rilievi formulati con il gravame.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sulla base dell’assunto che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria e tautologica, in quanto non vi era stato alcun accertamento sulle reali cause dell’allontanamento dell’imputata.
In particolare, nella motivazione della sentenza è stata richiamata la giurisprudenza precedente sull’argomento attraverso un excursus particolarmente interessante. Si legge, al riguardo: <<come già chiarito da questa Corte regolatrice, il reato di cui all’art. 570 co. 1 c.p., nella forma dell’abbandono del domicilio domestico, non può ritenersi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale (v.: Cass. Sez. 6, 14.7.1989 n. 13724, Chianta, rv. 182278 Cass. Sez. 6, 12.3.1999 n. 11064, Innamorato, rv. 214330)>>.
Considerato, inoltre, che <<la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge “abbandonato” (del che, nel caso oggetto di ricorso, nessuna prova è individuata né dall’impugnata sentenza di appello, né da quella di primo grado), occorre ribadire che - alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale - la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione>>.
Secondo la Corte, dai suesposti principi discende che <<la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale >>.
Tra le ragioni idonee a giustificare l’allontanamento di uno dei coniugi, la Corte di Cassazione individua l’impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che <<il compito del giudicante non può esaurirsi nell’accertamento del solo fatto storico dell’abbandono, ma include l’ineludibile ricostruzione del contesto concreto in cui esso si è verificato>>.
Orbene, nel caso oggetto della sentenza in esame, sia il Tribunale, sia la Corte territoriale si erano limitati ad accertare il mero dato oggettivo dell’allontanamento della moglie dal domicilio familiare, senza verificare l’eventuale esistenza di ragioni idonee a giustificare tale condotta materiale.
Senza tale accertamento, invero, non può essere verificato l’elemento soggettivo del reato26.
Dopo aver preso atto dell’incolmabile vuoto probatorio che ha caratterizzato l’intera vicenda processuale, la Corte Di Cassazione ha concluso con l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello impugnata perché il fatto criminoso attribuito alla ricorrente non costituisce reato.
Va, altresì, rilevato come, in linea generale, si ritiene che ciascun coniuge sia vincolato alla sua condizione e debba sottostare agli obblighi che ne derivano, compresi quelli penalmente sanzionati, finché non intervenga una pronunzia che sancisca l'invalidità ovvero lo scioglimento del matrimonio. Naturalmente, però, il venir meno del vincolo coniugale, non può assolutamente incidere sui figli.
Sull’argomento, si riportano qui di seguito alcuni principi, ribaditi in diverse occasioni, dall’orientamento giurisprudenziale consolidato.
In particolare, è stato ritenuto che:
-
l'eventuale dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare per il periodo precedente la dichiarazione stessa27;
-
fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualità e continuano, quindi, ad essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compresi quelli della coabitazione e della reciproca assistenza. Non ha alcuna rilevanza, pertanto, il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullità abbia effetto "ex tunc", e che tale effetto divenga efficace nell'ordinamento giuridico statuale in seguito al procedimento di deliberazione, poiché, nel frattempo, con riguardo alla norma penale, rimane integro il vincolo derivante dal coniugio28;
-
la separazione personale fa cessare la validità di alcuni obblighi contratti con il matrimonio e il divorzio scioglie il matrimonio stesso, ma tali effetti sono sempre circoscritti ai soli coniugi e non riguardano in alcun modo i figli, i quali conservano integri i loro diritti anche se i coniugi sono diventati fra di loro estranei o magari nemici29.
1.2.2. Segue: la condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie
L’altro modo, attraverso il quale si può realizzare la sottrazione agli obblighi di assistenza familiare, ai sensi del primo comma dell’art. 570 c.p., è il serbare “una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie”.
La genericità della formula, adottata dal Legislatore, ha dato origine ad alcuni dubbi interpretativi, considerato che i concetti di “ordine” e “morale”, più che costituire un parametro interpretativo, indicano dei valori etico-sociali che, in quanto tali, mutano con l’evoluzione dei tempi.
Con riferimento a siffatta condotta, invero, si percepisce in maniera ancora più forte l’avvenuto mutamento dei costumi sociali e della mentalità comune: quello che all’indomani dell’emanazione del codice Rocco, poteva ritenersi disdicevole dal punto di vista morale, oggi non lo è più.
Del resto, la genericità della formula era stata avvertita anche nella dottrina dell’epoca. Al riguardo, appaiono quanto mai attuali le espressioni utilizzate dal Manzini, il quale definì la locuzione “condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie”, come un contenitore in grado di comprendere qualsivoglia comportamento <<attivo od omissivo lesivo della compagine, della disciplina, dell’attività proficua, della prosperità, della sicurezza, della pace, della tranquillità, dell’onore, della dignità, della solidarietà o del buon costume della famiglia>>30.
In relazione alla predetta formula, fu sollevata anche la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 25, comma secondo, Cost..
Al riguardo, la Consulta, con sentenza n. 42 del 3 marzo 1972, respinse la questione, in quanto ritenne che la circostanza che il Legislatore abbia fatto ricorso a dei concetti extra giuridici diffusi e generalmente compresi dalla collettività, piuttosto che fare ricorso alla descrizione rigorosa e tassativa del fatto, non contrastasse con il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale.
Successivamente, si tentò di riproporre la questione, ma essa non arrivò al Giudice delle Leggi, poiché fu già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione.
In particolare, Cassazione penale, sezione I,13 dicembre 1983 precisò come la norma denunciata individuasse chiaramente la condotta ivi ipotizzata con riferimento alla violazione degli interessi dell'ordine e della morale della famiglia, in conformità delle statuizioni di cui agli artt. 145 e 147 c.c..
La pronuncia è particolarmente importante sia per il caso che ne era oggetto31, sia in quanto i giudici di legittimità precisarono il carattere sussidiario della locuzione.
Peraltro, in alcune pronunzie più recenti è stato ritenuto che la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, presa in considerazione dal comma 1 dell'art. 570 c.p., <<non è punita di per sé, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore>>32.
In particolare, nel caso oggetto della sentenza, dalla quale è stata tratta la massima sopra esposta, l'imputato era stato accusato di avere serbato una condotta contraria all'ordine familiare e di essersi sottratto agli obblighi inerenti alla sua qualità di coniuge e alla potestà di genitore, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie ed alla figlia, alle quali non aveva versato l'assegno, stabilito dal giudice in sede di separazione personale tra i coniugi.
Al riguardo, la Corte d’Appello, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, ribadiva che il comportamento che lo stesso aveva tenuto nei riguardi della figlia, già maggiorenne nel periodo oggetto di contestazione, doveva essere sussunto nella previsione di cui al 1° comma e non in quella di cui al 2° comma n. 2 dell'art. 570 c.p., in quanto si era comunque risolto in un'omessa assistenza morale verso la discendente.
Veniva, inoltre, precisato che ciò costituiva una mera riqualificazione del fatto, nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.); e che, in ogni caso, era stato accertato che aveva fatto mancare, violando così il 2° comma n. 2 della richiamata norma, i mezzi di sussistenza alla moglie, ammalata e priva di adeguate fonti di reddito, nonostante egli versasse in condizioni economiche idonee a fare fronte al proprio obbligo.
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, adducendo i seguenti motivi:
- le sue precarie condizioni economiche non gli avevano consentito di adempiere agli obblighi verso i familiari;
- omesso giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.;
- assenza di dolo, perché disoccupato e a carico della propria madre;
- il beneficio della sospensione condizionale non andava subordinato al pagamento della provvisionale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia.
Ciò in quanto, sebbene la condotta, tenuta dall'imputato nei confronti della figlia, fosse censurabile sotto il profilo morale, non assumeva rilievo penale e non integrava gli estremi del ritenuto reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p., in quanto l’addebito contestato si riferiva ad un arco temporale in cui la figlia aveva già raggiunto la maggiore età.
Inoltre, nella motivazione della sentenza, viene ribadito quanto già riassunto nella massima, ossia che la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p., non è punita di per sé, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.
Interessante è la motivazione logico giuridica fornita dalla Corte sul punto:
<<Ciò posto, è evidente, in particolare, che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, violazione certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, perché soltanto in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore - figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore. Il presidio penale a garanzia dell'assistenza morale ed economica, della solidarietà e della coesione familiare, in sostanza, è previsto, quanto alle responsabilità inerenti al rapporto di filiazione, per quei soli casi che assumono una connotazione di particolare gravità, perché evidenziano il non corretto esercizio o addirittura l'abuso della potestà genitoriale>>.
Tale principio è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Da ciò ne discende che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore33.
In particolare, nella vicenda oggetto della pronuncia in questione il figlio naturale dell’imputato e la di lui madre avevano proposto querela al compimento del trentesimo anno del primo, lamentandola mancata prestazione di contribuzione in danaro per tutto il periodo della minore età del ragazzo e dell'assoluto disinteressamento nei confronti dello stesso negli ultimi tredici anni.
La Corte territoriale escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 in ragione della tardività della querela, che risultava proposta oltre il raggiungimento della maggiore età, ritenendo integrato il reato di cui al comma 1 della disposizione richiamata, pur essendo stata formulata richiesta di punizione nello stesso termine, nel presupposto che l'obbligo di cui al comma 1 permanga anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’imputato, ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussite, dovendosi ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, nel caso in cui il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio avvenga in epoca notevolmente antecedente alla proposizione della querela34.
1.2.3. La violazione degli obblighi di assistenza morale
Con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che <<la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 cod. pen. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge>>.Di conseguenza, <<la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore>>.
E’ stato, altresì, precisato che <<gli obblighi di assistenza familiare possono essere violati anche nel caso di abbandono morale, e non solo nell’ipotesi di mancato mantenimento economico>>. Peraltro, tali obblighi <<nei riguardi dei figli non possono automaticamente cessare al raggiungimento della maggiore età, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e non abbiano trovato un’occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica>>35.
La sentenza, da cui è tratta la massima, in particolare, riguarda un uomo, il quale era stato tratto in giudizio per rispondere dei reati di:
-
omessa esecuzione continuata di provvedimento giudiziario (art. 81 c.p., art. 388 c.p., comma 2 allora vigente) per aver eluso l'esecuzione di ordinanza del Presidente del Tribunale, decurtando l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e delle due figlie affidate alla madre;
-
violazione degli obblighi di assistenza familiare, in quanto si era del tutto disinteressato, sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quello educazionale, delle figlie, rifiutando qualsivoglia contatto con le medesime. In tal modo, l’uomo si sottraeva per sua colpa agli obblighi di assistenza, inerenti alla potestà di genitore e alla qualità di coniuge.
Il Tribunale lo assolveva dal reato di cui agli artt. 81 e 388, comma 2, c.p., in quanto il fatto non era previsto dalla legge come reato, ma lo riteneva responsabile del contestato delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed al risarcimento del danno (da quantificarsi in separata sede civile) in favore delle due parti civili.
L’imputato proponeva, attraverso il proprio difensore, ricorso immediato per Cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p.
In particolare, tra gli altri, veniva dedotto il vizio di legittimità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 570, comma 1, c.p., anche in relazione all'art. 147 c.c., posto che il giudice aveva individuato in maniera impropria i profili relativi alla condotta penalmente rilevante, alla qualità delle persone offese ed alla specificazione degli obblighi di assistenza familiare.
In primo luogo, secondo la difesa, era stato trascurato il dato secondo cui l'abbandono del domicilio domestico fosse giustificato dalla separazione consensuale, intervenuta tra il ricorrente e la moglie, separazione che, in seguito, era sfociata nella declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conseguentemente, l'ex consorte dell'imputato non poteva vantare diritti di sorta (coabitazione, assistenza) dopo lo scioglimento del vincolo coniugale.
Per quanto concerneva il comportamento di disinteresse nei confronti delle figlie, la sentenza impugnata ne aveva dato una lettura distorta, soprattutto relativamente all’elemento oggettivo della fattispecie, considerato che gli obblighi penalmente sanzionati sono soltanto quelli che derivano da diritti-doveri di carattere materiale ed economico. Pertanto, <<esulerebbe dalla previsione dell'art. 570 ogni comportamento meramente morale che possa genericamente e/o deduttivamente rientrare nella generale nozione di assistenza familiare. Doverosamente letta alla luce dell'art. 147 c.c., l'assistenza evocata dall'art. 570 c.p. è per il ricorrente riferibile ai soli figli minori o, tutto al più, ai figli che pur maggiorenni non abbiano terminato gli studi o non abbiano un lavoro, non essendo altrimenti autosufficienti>>.
Il Tribunale aveva, altresì, omesso di considerare che le due figlie da tempo svolgevano un’attività lavorativa ed erano autonome: <<L'ulteriore inferenza è che il Tribunale ha esageratamente allargato i limiti funzionali e temporali degli obblighi giuridici facenti capo al genitore (la sentenza fa riferimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, alla protrazione del reato per circa venti anni), tralasciando di considerare che da tempo le due figlie del ricorrente (una sola delle quali costituitasi parte civile) hanno raggiunto una propria autonomia lavorativa, reddituale e familiare (formando propri nuclei familiari anche con figli). Sicché il giudice avrebbe dovuto riscontrare l'avvenuta cessazione della permanenza del reato e dichiararne la maturata prescrizione>>.
La Suprema Corte ha mostrato di non condividere le censure mosse dal ricorrente, anche alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la norma in questione comprende condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed, altresì, di assistenza soltanto morale.
Conseguentemente, <<commette il reato anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre (la somministrazione dei mezzi di sussistenza o sopravvivenza non esaurendo gli obblighi scaturenti da tali qualità)>>.
Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale non ha affrontato la problematica della durata dell'apprezzabilità del contegno omissivo del genitore imputato nei riguardi delle due figlie, dopo il rispettivo superamento della minore età: <<Non v'è dubbio che gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei riguardi dei figli non possano automaticamente cessare al raggiungimento della maggiore età, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e/o non abbiano trovato una occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica (solo a tal punto venendo in gioco, parafrasando il ricorso, meri obblighi etici giusnaturalistici di assistenza o solidarietà da parte del genitore). Nondimeno non è possibile evocare la natura permanente del reato per accreditare una impropria sorta di imperitura sussistenza del reato ex art. 570 c.p., comma 1>>.
La Corte ha, peraltro, censurato il comportamento del giudice di merito, in quanto <<si rendeva, quindi, doveroso per il giudice di merito verificare la temporalità della condotta violatrice degli obblighi assistenziali da parte del (…) in rapporto alla evoluzione (una volta divenute maggiorenni) delle peculiari situazioni individuali delle due persone offese>>.
Sulla base di siffatte considerazioni, è stata cassata la sentenza di primo grado.
1.2.4. L’art. 570, comma secondo, c.p.: la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge
La seconda modalità mediante la quale può essere integrato il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è costituita dalla malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore ovvero del coniuge36.
Siffatta fattispecie è autonoma rispetto alle altre, contemplate dalla norma, ed integra, piuttosto, un’ipotesi di delitto contro il patrimonio.
Una parte della dottrina37 ha individuato nella norma una sorta di deroga all’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”.
La disposizione in esame statuisce la non punibilità di alcuni congiunti, che abbiano commesso taluno dei fatti, previsti dal titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio. In particolare, i congiunti non punibili sono il coniuge non legalmente separato, l’ascendente o il discendente o l’affine in linea retta, l'adottante o l'adottato, il fratello o la sorella conviventi con la persona offesa.
E’, altresì, prevista la perseguibilità a querela, qualora il fatto sia commesso a danno del coniuge legalmente separato.
La dottrina in questione, invero, individua la ratio della deroga de qua nel rapporto fiduciario, sulla scorta del quale il diritto civile affidava al capofamiglia l’amministrazione esclusiva dei beni dotali del coniuge, di quelli della comunione e di quelli del figlio minore. Tali soggetti, si ricorda, erano ritenuti incapaci di amministrare o gestire il loro patrimonio.
Per quanto concerne i beni del figlio minore, va rilevato come la riforma del diritto di famiglia38 abbia fatto venir meno il regime di amministrazione esclusiva del padre ed abbia introdotto il principio secondo cui entrambi i genitori hanno la funzione di rappresentanza ed amministrazione da esercitarsi, a seconda dei casi, congiuntamente o disgiuntamente39.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che <<In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la configurabilità del reato di malversazione di beni del figlio minore non è esclusa dalla circostanza che il soggetto attivo sia il genitore separato non affidatario>>40.
La vicenda, oggetto della pronuncia in questione, trae origine dalla denuncia della madre del minore, coniuge separata la quale aveva lamentato la condotta di appropriazione-malversazione-dilapidazione del patrimonio del comune figlio ad opera del coniuge.
In particolare, quest’ultimo aveva la disponibilità di 7 BTP dategli dal di lui padre, per provvedere alle spese di studio del minorenne nipote, ed aveva in parte incassato i contanti ed in parte trasferito le cedole a terzi.
La sentenza in questione è particolarmente interessante in quanto la Corte di Cassazione precisa che il genitore non esercente la potestà e non amministrante i beni del minore ben può essere soggetto attivo del delitto di malversazione di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 1.
Ciò in quanto <<la lettera della norma de qua, nel sanzionare penalmente nel capo 4^ del libro 2^ la malversazione-dilapidazione dei beni del figlio minore, nel quadro dei delitti contro l'assistenza familiare, non indica affatto che il "malversante genitore" oltre che titolare, debba anche avere l'esercizio in concreto della potestà.
Non a caso, prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale e della riforma del diritto di famiglia (salvo qualche isolata opinione in dottrina), si riteneva che potesse essere soggetto attivo del delitto anche la madre del minore la quale, all'epoca, aveva sì la "titolarità" ma non "l'esercizio della potestà", in allora rigorosamente "paterna", tipicamente esercitata dal padre ex art. 316 c.c., ed esercitata dalla madre soltanto dopo la morte del padre stesso e negli altri casi tassativamente stabiliti dalla legge>>.
Nella configurazione dell'illecito, quindi, appare irrilevante la circostanza che il genitore non fosse esercente la potestà sul figlio.
A conforto delle superiori considerazioni, la Corte richiama la giurisprudenza sull’argomento, secondo cui persino il radicale provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venir meno "i poteri" del genitore decaduto, ma non i "doveri" che non siano incompatibili con le ragioni che hanno dato causa al provvedimento stesso.
Conseguentemente, permanendo in capo al genitore decaduto, sia i doveri di natura economica che quelli di natura morale, il provvedimento ablativo della potestà non fa venir meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2.
Precisa ancora la Corte che <<sè è pacifico che lo stato di separazione coniugale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonchè di collaborazione tra gli stessi (Cass. Penale sez. 6^, U.P. 30.9.98 Moranda e U.P. 1.2.99 Valente), a maggior ragione, tale status di separato non può certo incidere negativamente sui doveri elementari e costituzionalmente sanciti verso i figli, ex art. 30 Cost. e art. 147 c.c.. Pertanto la condizione di "genitore-coniuge-separato" non comporta alcuna inammissibile restrizione dell'obbligo di mantenimento, il quale non si sostanzia soltanto in atti positivi di dazione ma anche, come non avvenuto nella specie, nell'obbligo di una oculata, scrupolosa, attenta e funzionale amministrazione dei beni dei figli minori, esigenza questa, tra l'altro, amplificata nel suo valore pragmatico per il contesto di disgregazione familiare>>.
1.2.5. Segue: l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza
L’ultima ipotesi prevista dall’art. 570 c.p. è quella relativa alla violazione dell’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato (per colpa)41.
Tale ipotesi è quella che più frequentemente si presenta nella prassi giudiziaria.
La previsione pone immediatamente il problema della differenza tra mezzi di mantenimento ed alimenti.
Ciò in quanto l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., fa riferimento ai mezzi di sussistenza, che sono concetto diverso dall'essere inadempiente rispetto agli obblighi civilistici di mantenimento o di prestare gli alimenti.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che per «mezzi di sussistenza», debba intendersi ciò che è strettamente indispensabile all’esistenza, indipendentemente dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l'istruzione dei figli, il vestiario42.
Invece, l'obbligo di «mantenimento» dei figli o del coniuge non economicamente autosufficienti, ha una portata molto più ampia, poiché comprende in sé tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi e, conseguentemente, per il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita, indipendentemente dallo stato di bisogno.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che << In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)>>43.
In ogni caso, il delitto de quo non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile. Al riguardo è importante evidenziare come l'inosservanza, anche parziale, non importa automaticamente l'insorgere del reato. Affinchè sussistano i presupposti per l’applicabilità delle fattispecie de qua, è necessario:
- che gli aventi diritto all'assegno alimentare si trovino in stato di bisogno;
- che l'obbligato ne sia a conoscenza;
- Che l’obbligato sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza44.
In ogni caso, essendo l’ambito di applicazione dell'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. circoscritto alla mancata corresponsione da parte dell'obbligato dei soli mezzi di sussistenza, si ritiene che non sussista interdipendenza alcuna tra siffatta omissione e l'assegno stabilito dal giudice in sede civile, sia nel caso in cui tale assegno venga corrisposto nella misura stabilita, sia qualora venga autoridotto o non sia affatto versato45.
Al riguardo, infatti, in passato, è stato precisato che <<il reato previsto dall'art. 570 c.p. risulta integrato allorché la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza al familiare>>46.
Invero, l'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel punire la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, tutela una categoria più ristretta di soggetti, rispetto a quella tutelata in sede civilistica: il coniuge non legalmente separato per sua colpa (con addebito a suo carico), i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro e gli ascendenti.
Particolarmente evidente è la differenza con riferimento ai figli maggiorenni.
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018, ha fornito chiarimenti in merito al mantenimento del figlio maggiorenne, statuendo, ancora una volta, che la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti, non integra il reato in questione. Ciò in quanto l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile47.
Pertanto, <<la violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva verso i figli, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene a esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà del genitore>>48.
I figli maggiorenni, nati dal matrimonio, allo stato della legislazione vigente, potranno trovare tutela penale, ai sensi dell’art. 570 bis c.p.49
Un'altra nozione che la giurisprudenza ha tentato di chiarire è quella di persone inabili al lavoro.
Sul punto, è stato precisato che con tale locuzione il Legislatore non ha voluto fare riferimento alle sole menomazioni fisico-psichiche, ma, in realtà, essa comprende anche la disoccupazione involontaria50.
Ciò in quanto lo stato di disoccupazione del figlio ultradiciottenne, non riconducibile alla sua volontà, è una causa esterna che incide negativamente sull'abilità al lavoro del medesimo figlio, il quale, nonostante non abbia delle menomazioni fisiche o psichiche, ovvero sia affetto da altre notevoli infermità, è ugualmente impossibilitato a condurre una attività lavorativa.
Siffatta interpretazione, peraltro, è confortata dall’art. 38, comma 2 Cost., disposizione che parifica l'infortunio, la malattia, l'invalidità e la vecchiaia alla disoccupazione involontaria51.
1.2.6. Lo stato di bisogno dei figli minori
Problemi interpretativi analoghi a quelli evidenziati nel precedente paragrafo, si sono posti con riferimento allo stato di bisogno del figlio minore.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata corresponsione dell'assegno, stabilito in sede di separazione dei coniugi, per il mantenimento del figlio minore, integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata laddove il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno52.
L’obbligo di assistenza incombente sul genitore viene meno temporaneamente, esclusivamente nel caso di incolpevole e temporanea difficoltà economica, la quale determini una situazione di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera adeguata e congrua, le esigenze vitali dei figli e del coniuge separato.
In siffatte ipotesi, il genitore che non riesce a coprire l'assegno di mantenimento deve essere assolto, qualora fornisca la prova della predetta situazione di indigenza53.
Ciò in quanto, affinché il mancato versamento di assegni di mantenimento non integri il reato di violazione di obblighi di assistenza familiare, è necessario provare l’impossibilità all’erogazione dei suddetti assegni; diversamente, verranno integrati gli estremi del reato in questione54.
In ogni caso, non è sufficiente ad evitare la responsabilità penale la circostanza che il genitore faccia dei regali ai figli o ponga in essere versamenti saltuari.
Infatti, <<non si può tener conto in nessun modo, poi, delle modeste elargizioni in danaro erogate direttamente al minore e non al genitore affidatario, non esistendo alcuna garanzia circa la effettiva destinazione di tali somme ai bisogni essenziali del minore; e tanto meno si può tenere conto di doni in natura che non siano destinati a soddisfare tali bisogni>>55.
La sentenza appena riportata appare interessante anche per l’altro principio in essa stabilito, ossia che <<il reato si consuma anche in caso di corresponsione integrale dell'assegno, quando il suo importo sia manifestamente inadeguato ad assicurare all'alimentando la soddisfazione degli stessi bisogni elementari dell'esistenza, cui l'obbligato ha l'onere di provvedere indipendentemente da qualsiasi statuizione del giudice civile e dai suoi limiti>>.
A maggior ragione, la decurtazione arbitraria dell’assegno, dipendente dal fatto volontario dell'obbligato, incide necessariamente sull'adempimento dell'obbligazione alimentare ed integra i presupposti del delitto in questione, qualora il soggetto passivo non disponga di redditi propri, circostanza, peraltro, normale nel caso di minori, e nel caso in cui l'assegno sia di importo appena adeguato ad assicurare l’esistenza dello stesso.
In alcune decisioni, invece, si è ritenuto che, per la sussistenza del reato, si può prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno del figlio minorenne56.
Ciò in quanto <<la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per il genitore obbligato di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza>>.
In ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori non viene meno nel caso in cui gli aventi diritti abbiano ottenuto dei sussidi comunali di sostentamento57.
In particolare, si legge nella motivazione della sentenza n. 38127/2009: <<per quel che attiene alla pur sostenuta insussistenza probatoria dell'elemento materiale del reato, rappresentato dallo stato di bisogno delle persone offese (moglie separata e tre figlie minori), le notazioni del ricorrente si mostrano meramente assertive e all'evidenza infondate. Al riguardo è agevole considerare - in primo luogo - che nessuna incidenza può riconoscersi al dato per cui la (…) e le figlie sono state supportate nel far fronte alle loro primarie esigenze di vita dai familiari della donna e da provvidenze pubbliche, atteso che - come chiarito da questa Corte regolatrice - in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno e l'obbligo di contribuire al mantenimento, quanto meno dei figli minori, non vengono meno, qualora gli aventi diritti ricevano assistenza economica da terzi>>.
La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che qualora l'omesso mantenimento riguardi i figli minori, la prova dello stato di bisogno del beneficiario è del tutto superflua, in quanto tale elemento risulta dimostrato, "in re ipsa", dall'incapacità dei minori di attendere direttamente alle proprie necessità.
In siffatte ipotesi, peraltro, su ritiene che la situazione concreta di aiuto proveniente da terzi o dall'altro coniuge non esclude assolutamente il reato58.
Tale orientamento è stato recentemente superato59. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che l’obbligo di mantenimento deve essere tenuto distinto da un effettivo stato di bisogno dei destinatari dei versamenti, dovendosi individuare in quanto è necessario per la sopravvivenza, anche alla luce di ulteriori esigenze complementari, quali, ad esempio, abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili.
Si legge nella parte motiva della sentenza citata in nota che “ A fronte delle accertate circostanze di cui sopra, il Tribunale e poi la Corte hanno alluso ad un "grave disagio e effettivo stato di bisogno" di moglie e figli riportando alcune massime della Corte di Cassazione circa la nozione di stato di bisogno, circa la presunzione di esistenza di esso in casi di figli minori e circa l'ininfluenza di versamenti e corresponsioni di denaro da parte di familiari ed altre persone che non si confrontano però criticamente con i dati di fatto sopra accertati e richiamati, che lascerebbero invece trasparire, in ragione del fatto che la somma versata era comunque di un qualche rilievo economico e della circostanza che il ridotto adempimento era durato per pochi mesi, una sostanziale inesistenza di un effettivo stato di bisogno dei destinatari dei versamenti, tenuto esso distinto dall'obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze quali abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili (Cass. Sez. Unite 31/1/2013 n. 23866, Rv 255272 e Cass. Sez. 6, 21/11/2008, n. 2736, Rv 242855)”.
Sulla base di tale argomentazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano, la quale, in sede di rinvio, sarà tenuta ad accertare l'effettività dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori dell'imputato durante il ristretto periodo temporale in cui egli ha ridotto l'importo versato.
1.2.7. L’impossibilità economica dell’obbligato
L'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la "capacità economica" dell'obbligato.
Purtroppo, spesso in questo tipo di fattispecie si combatte “la guerra dei poveri”, in quanto da un lato vi sono dei figli minori privi di mezzi di sostentamento e dall’altro un genitore a sua volta privo di reddito.
Naturalmente, occorre distinguere i casi in cui tale capacità di reddito è preordinata al tentativo di sottrarsi al mantenimento dei figli e/o del coniuge da quelli in cui manchi una vera e propria capacità economica dell’obbligato.
Sull’argomento, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini di sanzionarne penalmente l'inadempimento (art. 570, comma 2 n. 2, c.p.), è necessario che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità persistente, oggettiva e incolpevole di introiti sufficienti a soddisfare le "esigenze minime di vita60.
In particolare, il caso che ha dato origine alla vicenda processuale sottesa alla sentenza in questione riguardava un sordomuto, il quale percepiva il solo reddito pensionistico per invalidità pari a circa 3.150 euro all'anno e gli era stato contestato di non avere versato la somma di 150 euro mensili in favore della figlia minore.
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza di condanna della Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, pur ritenendo che le entrate dell'obbligato erano "modestissime" e apprezzando lo stato di "disagio economico" in cui lo stesso versava, aveva ritenuto la sussistenza del reato61.
Il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27051/2011 è stato confermato anche da Cassazione penale, sez. VI, 22/09/2011, n. 35612, la quale ha ribadito che con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione di impossibilità economica dell'obbligato deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
La pronuncia ha, altresì, specificato che la prova di tale impossibilità incombe in capo all'obbligato e non può ritenersi soddisfatta con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato.
Applicando i suesposti principi, i giudici di legittimità hanno confermato la condanna inflitta ad un uomo per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e alla figlia minore.
La giurisprudenza ritiene, inoltre, che, affinché si configuri il reato di cui all'art. 570 c.p., è necessario l'accertamento della sussistenza della concreta capacità economica dell'obbligato a fornire i mezzi d sussistenza62.
Sulla scorta dei principi sopraesposti, è stata annullata la sentenza di condanna nei confronti di un padre inabile al lavoro, che avrebbe dovuto versare l'assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d'invalidità.
Con la sentenza n. 36636, depositata il 2 settembre 2014, la sesta sezione penale si è ancora una volta occupata dell’argomento, chiarendo quali sono le situazioni di incapacità economica che assumono rilevanza ai fini della difesa dell’imputato che non ha fatto fronte ai propri obblighi.
La Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati che sono stati espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato consiste nell’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p. Tale incapacità deve:
- essere assoluta;
- integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
La Corte ha ribadito che incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione e che la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione, di una mera flessione degli introiti economici o di difficoltà.
In buona sostanza, l’imputato deve provare che le difficoltà addotte siano tali da determinare una vera e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad adempiere63.
I giudici hanno inoltre affermato che la violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta un reato permanente che si protrae per tutto il periodo in cui perdura l’omesso adempimento. Ne deriva che la cessazione della permanenza coincide con il sopraggiunto pagamento o con l’accertamento della responsabilità penale nel giudizio di prime cure.
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la generica allegazione di difficoltà economiche non esclude il reato di cui all’art. 570 c.p.64.
Ciò in quanto il padre, che fa mancare i mezzi di sussistenza alla figlia, risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), se non dimostra in maniera specifica di essere assolutamente impossibilitato, a causa di una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti, ad adempiere alla sua obbligazione. Infatti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà non escludono il reato de quo65.
1.3. L’elemento soggettivo
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dottrina tradizionale ritiene necessaria la sussistenza del dolo, consistente nella volontà cosciente e libera e nell'intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, escludendosi la punibilità del reato a titolo di dolo eventuale o colpa66.
Un orientamento opposto, tuttavia, si è registrato in seno ad alcune decisioni di merito, nelle quali è stata riconosciuta la sussistenza del reato anche nel caso in cui l'obbligato versava in stato di incapacità economica, a causa di una condotta ritenuta dal giudicante colposa67.
Tale orientamento, a dire il vero, è stato portato alle estreme conseguenze da una pronuncia di legittimità, ove, addirittura, è stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato, il quale non abbia fatto valere il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni compatibili con la sua parziale invalidità e, per ciò stesso, abbia tenuto un comportamento negligente e, di conseguenza, colposo.
Secondo tale pronuncia, la semplice colpa dell'obbligato per il suo stato di incapacità economica non è idonea ad escludere la sussistenza del reato68.
La decisione in esame, invero, ha suscitato in dottrina alcune perplessità, in quanto non può condividersi il riconoscimento, a titolo di colpa, dell'imputabilità ai sensi dell’art. 570 c.p.69.
Tale dottrina, infatti, ha ritenuto più conforme ai principi generali, una ricostruzione dell’elemento soggettivo in termini di dolo generico, in quanto confacente ai confini naturali delineati dal legislatore.
Ciò, naturalmente, non esclude la possibilità di ritenere punibile la condotta di omessa prestazione dei mezzi di assistenza anche a titolo di dolo eventuale, qualora venga dimostrato che il soggetto attivo del reato abbia previsto che, mediante il suo comportamento negligente, avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto e, tuttavia, ne abbia accettato il rischio.
Tale orientamento, peraltro, ha trovato riscontro in giurisprudenza, la quale ha ritenuto la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, il quale si era dimesso dall'impiego di metronotte, al fine di precostituirsi una situazione di apparente disoccupazione70.
Con riferimento all’elemento soggettivo, si è posto il problema della rilevanza dell’errore sulla legge penale, nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. consista nell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, da parte di un genitore, qualora l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole.
In tale ipotesi, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, non può avere rilievo, in quanto si traduce in errore sulla legge penale, non scriminante, ai sensi dell'art. 5 c.p. In siffatta ipotesi, infatti, non ricorre un caso di ignoranza scusabile di una norma, tra l'altro corrispondente a un'esigenza morale universalmente avvertita71.
Il principio è stato, altresì, ribadito da una pronuncia successiva72, con la quale è stato ritenuto che per escludere l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., commesso in danno del figlio minore, non rileva l'asserita convinzione dell'imputato circa la concreta insussistenza dello stato di bisogno del figlio, basata sulla considerazione che l'altro genitore non gli aveva mai chiesto alcun contributo per il mantenimento: tale convincimento, infatti, traducendosi in errore non scusabile sulla legge penale, non scriminerebbe la violazione di un dovere primario, quale è quello di non far mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza, che è esigenza morale universalmente avvertita.
In pronunce più recenti, la corte di Cassazione ha ritenuto che:
-
L'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato realizza la condotta illecita prevista dall'art. 570, comma 1, c.p. solo quando si accerti che tale inadempimento economico si riconnette ad una volontà direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia; occorre, dunque, verificare la condizione economica dell'obbligato per accertare se questa, e non il consapevole disconoscimento degli obblighi familiari, sia stata causa dell'inadempimento, eventualità che escluderebbe la configurazione della fattispecie tipica (nella specie, la corte ha ritenuto incompleta la verifica delle condizioni economiche dell'obbligato, soggetto effettivamente indigente a causa del licenziamento subito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, condizioni che non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito)73.
-
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., l'obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell'accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo status. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato in ordine alla sussistenza della predetta consapevolezza, alla luce sia delle informazioni prontamente fornite dalla madre del minore all'imputato fin dalla fase della gestazione, sia dalla successiva condotta tenuta da quest'ultimo, rifiutatosi sistematicamente di effettuare gli accertamenti sanitari idonei a far chiarezza sulla paternità)74.
Prima di concludere la disamina sull’elemento soggettivo del reato de quo, va rilevato come l’elemento psicologico possa ravvisarsi anche nella forma di dolo eventuale.
Sull’argomento la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi diversi anni fa relativamente ad un famoso caso relativo all'interruzione di cure emotrasfusionali alla figlia minore talassemica da parte di genitori testimoni di Geova.
L'inconciliabilità tra gli obblighi di coscienza propri della fede religiosa dei genitori e la necessità di cura per la figlia venne inizialmente risolta dal Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'imposizione coattiva della cura della bambina, cure a cui, in un primo momento, i genitori si assoggettarono senza necessità di coazione diretta.
Tuttavia, a causa di seri problemi derivanti da gravi carenze delle strutture sanitarie, la frequenza delle trasfusioni scemò radicalmente, comportando un progressivo degrado biologico degli organi vitali della piccola, fino a provocarne la morte.
La Suprema Corte, nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna dei genitori per omicidio volontario, ha evidenziato che la definizione di dolo ai sensi dell’art. 43 c.p. richiede, non la semplice previsione dell'evento, ma la proiezione della volontà verso la produzione di esso; ciò vale anche per il dolo eventuale, il quale presuppone che l'azione sia diretta al conseguimento volontario di un certo risultato, sia pure con la prospettiva di conseguirne uno diverso che, non distogliendo l'agente dalla prosecuzione della condotta, entra per ciò stesso nel fuoco della volontà Sulla scorta dei superiori principi la Corte di Cassazione ha ritenuto i genitori colpevoli dei reati di cui agli artt. 570 e 586 c.p (violazione degli obblighi di assistenza familiare seguita da morte come conseguenza non voluta )75.
Sempre con riferimento al dolo eventuale, al fine della configurabilità dell'elemento soggettivo nel delitto di cui all'art. 570 c.p. è stato ritenuto sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto doloso, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli76.

Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:
Manuale di diritto di famiglia Sesta Michele, CEDAM, 20192. Problematiche interpretative postesi in giurisprudenza in relazione all’art. 570 c.p.
2.1. Il luogo di adempimento dell’obbligazione contributiva di cui all’art. 570 c.p.
Quale è il luogo di adempimento dell’obbligazione contributiva di cui all’art. 570 c.p.?
La Suprema Corte di Cassazione77 ha risposto individuando tale luogo in quello di residenza dell'avente diritto.
La vicenda che ha dato origine al procedimento da cui è scaturita la sentenza in oggetto, riguarda un padre, riconosciuto per ben due volte, con due distinte sentenze, colpevole del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio minorenne, affidato alla moglie separata.
Quest’ultima, dopo la separazione coniugale, si era trasferita in un'altra città per motivi di lavoro ed il marito si era completamente disinteressato del figlio minore.
I giudici di merito avevano fondato la condanna dell’imputato sulla sua inadempienza contributiva correlata all'immanente stato di bisogno del figlio minorenne privo di autonome fonti di reddito ed all’assenza di qualsiasi causa ostativa al rispetto dell'obbligo da parte dell'imputato.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su ricorso dell’imputato, dopo aver disposto la riunione del secondo ricorso con il primo, ha ribadito dei principi molto interessanti sull’argomento, oggetto della presente trattazione78.
In particolare, i giudici di legittimità confermano il principio di diritto ampiamente illustrato nel capitolo 1, ossia che <<l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro od anche con l'aiuto di altri familiari, poichè tale sostituzione surrogatoria non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, da reputarsi presunto o comunque immanente nella sua condizione di minore età e di assenza di fonti di reddito personali>>.
Ciò in quanto la mera indicazione di uno stato di difficoltà finanziaria dell'obbligato non è sufficiente a caducare l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli di età minore, qualora non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in una situazione di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, pur in parte, alla prestazione.
Peraltro, l'onere di allegare idonei e convincenti dati rappresentativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi grava sull’imputato.
Secondo la Suprema Corte, detto onere non è stato in alcun modo rispettato nel caso in questione, tenuto conto della circostanza accertata nei giudizi. di merito, che egli ha sempre svolto attività lavorativa.
La sentenza de qua esamina anche la questione della competenza territoriale, ritenendo che <<nell'ipotesi di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, la competenza territoriale è determinata dal luogo di effettiva dimora dell'avente diritto ai mezzi di sussistenza. Nel caso di specie del figlio minore dell'imputato e, in nome e per conto dello stesso, della madre affidataria>>.
Siffatta conclusione, si legge nella sentenza in commento, <<in tema di luogo di adempimento dell'obbligazione contributiva ex art. 570 cpv. c.p., è, del resto, funzionale alla specifica natura dell'obbligazione in parola. Si tratta di una obbligazione periodica geneticamente pecuniaria, o c.d. di valuta, integrata dalla corresponsione con scadenza mensile di una somma di denaro determinata dal giudice civile. L'obbligazione rientra nel novero delle obbligazioni definite "portable", nel senso che debbono essere "portate", cioè adempiute, presso il domicilio del creditore, secondo il generale principio fissato dall'art. 1182 c.c., comma 3, ("L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza")>>.
Da ciò ne consegue che, al fine di individuare il forum destinatae solutioms ex art. 20 c.p.c. è necessario localizzare il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, luogo che determina la competenza territoriale di un inadempimento dell'obbligazione penalmente rilevante.
Orbene, nella vicenda oggetto della pronuncia in questione i giudici di merito hanno correttamente individuato quel luogo (posto in cui hanno dimorato - nei periodi di tempo oggetto delle contestazioni penali - il figlio minore e la moglie separata (aventi diritto e creditori) dell'imputato).
2.2. Violazione degli obblighi di assistenza familiare e risarcimento del danno
Il figlio (legittimo o naturale), che sia stato sempre totalmente ignorato da un genitore sia dal punto di vista economico, sia da quello affettivo, psicologico e sociale, può ottenere il risarcimento del danno esistenziale subìto?
Alcune sentenze di merito hanno risposto positivamente al superiore quesito.
In particolare, il Tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 2011, partendo dall’assunto che il danno morale e il danno esistenziale costituiscono due distinti profili del cd. danno non patrimoniale, risarcibili, ha ritenuto che un figlio abbandonato dal genitore possa avanzare domanda di risarcimento del danno esistenziale, individuato e qualificato quale modificazione peggiorativa dei propri rapporti relazionali e delle proprie abitudini di vita, ossia il danno conseguente al raffronto tra la situazione sociofamiliare goduta, in concreto, dalla vittima rispetto alla situazione di cui avrebbe potuto beneficiare ove il genitore avesse, invece, ottemperato ai propri doveri parentali.
Tuttavia, vengono poste le seguenti condizioni:
- chi chiede il risarcimento deve dimostrare, anche in via presuntiva, le rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subìta, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione79;
- la cifra richiesta non deve essere, in ogni caso, punitiva perché sproporzionata od eccessiva. A tal fine, il giudice può legittimamente fare riferimento, in via equitativa, alle tabelle comunemente applicate, per quantificare il danno, nel caso della morte di un familiare.
Il Tribunale di Cagliari, 25/08/2006, n. 2247, invece, ha ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo, ai sensi dell’art. 2059 c.c. e 185, comma 2, c.p., nel caso in cui il genitore abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al proprio figlio naturale con ciò integrando gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Ed ancora, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17144/18 del 12.09.2018, ha ritenuto che anche l’’omesso pagamento dell’assegno divorzile (art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970 n. 898) obbliga l’autore di tale condotta al risarcimento del danno morale in favore dell’ex coniuge.
2.3. I rapporti tra la perdita della patria potestà e l’obbligo di mantenimento
Il genitore che non esercita la potestà possa essere soggetto attivo del reato80.
I giudici di legittimità hanno ritenuto possibile tale circostanza, sulla base dell’assunto che la lettera dell’art. 570 c.p., sanzionando penalmente la malversazione-dilapidazione dei beni del figlio minore, nell’ambito dei delitti contro l'assistenza familiare, non richiede assolutamente che <<il "malversante genitore" oltre che titolare, debba anche avere l'esercizio in concreto della potestà>>.
Tale assunto, in ogni caso, trova conforto nell’interpretazione formatasi prima della riforma del diritto di famiglia, secondo la quale la madre, pur non esercitando la potestà, poteva rendersi autrice del reato in questione81.
La giurisprudenza ritiene, che la qualità di genitore e coniuge separato, nella vicenda oggetto della decisione, è del tutto ininfluente, in quanto se da una parte è pacifico che lo stato di separazione coniugale, <<pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione tra gli stessi, a maggior ragione>> tale status di separato non può certo incidere negativamente sui doveri elementari e costituzionalmente sanciti verso i figli, ex art. 30 Cost. e art. 147 c.c..
Pertanto, <<la condizione di "genitore-coniuge-separato" non comporta alcuna inammissibile restrizione dell'obbligo di mantenimento, il quale non si sostanzia soltanto in atti positivi di dazione ma anche, come non avvenuto nella specie, nell'obbligo di una oculata, scrupolosa, attenta e funzionale amministrazione dei beni dei figli minori, esigenza questa, tra l'altro, amplificata nel suo valore pragmatico per il contesto di disgregazione familiare>>.
Sempre con riferimento alla perdita della potestà genitoriale, la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la perdita della patria potestà non può essere addotta dal genitore obbligato al mantenimento della prole come motivo legittimo tendente a giustificare il mancato pagamento degli assegni dovuti82.
Conseguentemente, la pronuncia della decadenza dalla potestà dei genitori lascia del tutto inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, doveri la cui violazione è penalmente sanzionata.
Da ciò ne discende che <<il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, cod. pen. e non ne fa venire meno la permanenza>>.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto la pretesa dell’imputato priva di fondamento.
2.4. La natura del reato e l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza a carico di più familiari conviventi
Con riferimento alla natura del reato in questione, nel 2008 è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto che si era formato sull’argomento.
Un primo orientamento, infatti, riteneva che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonostante la pluralità di condotte, avesse natura unitaria, in quanto le condotte tipiche sono lesive di un bene giuridico unico e superiore, consistente nell’equilibrio, nella cura e nello sviluppo del nucleo familiare nella sua interezza.
Al riguardo, è stato, infatti affermato che <<la norma penale indica come oggetto di repressione una condotta indifferenziata rispetto al numero ed alla qualità dei soggetti lesi, sicché in sostanza il legislatore, non considerando singolarmente le posizioni degli individui, difende il complesso di obblighi che fa capo alla famiglia come entità distinta dai suoi componenti>>83.
Un secondo orientamento, peraltro minoritario, invece, riteneva la natura pluralista del delitto de quo, delitto tendente a tutelare non già il nucleo familiare nel suo complesso, bensì il singolo individuo che ne faccia parte.
In particolare, è stato ritenuto che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non già l'ordine familiare. Da ciò ne discende che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.
Pertanto, colui il quale, con una sola omissione, faccia mancare i mezzi di sussistenza a più familiari, commette non uno,ma tanti reati quanti sono i familiari al cui obbligo di assistenza è venuto meno, con la conseguenza che, trattandosi di un concorso formale, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all'art. 81 c.p.84.
Le Sezioni Unite hanno fatto proprio quest’ultimo orientamento minoritario, statuendo che “configura una pluralità di reati l’omessa somministrazione di mezzi di sussistenza nell’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare”85.
In buona sostanza, è stato ritenuto che le condotte descritte dall’art. 570 c.p. non possono essere ricondotte ad una categoria omogenea e, per tale ragione, devono essere diversificate. Si legge, al riguardo, nella motivazione della sentenza in commento: “Si tratta di una norma che fa riferimento ad un ventaglio di condotte di natura diversa che, fermo restando il fine di tutela della famiglia e dei rapporti di assistenza nell’ambito familiare, prende in considerazione condotte ed eventi di diversa natura per i quali ben possono individuarsi beni non omogenei ma parimenti tutelati”.
Ciò anche in considerazione della circostanza che, in sede penalistica, sussistono delle difficoltà nella ricostruzione di un concetto unitario di famiglia.
Alquanto interessante è l’iter argomentativo seguito dalla Corte. Conseguentemente appare opportuno riportare l’intera motivazione, data dalle Sezioni Unite, sul punto.
<<Ritengono le sezioni unite che la soluzione corretta del problema sia quella proposta dal secondo orientamento riferito anche se il percorso argomentativo di queste decisioni non appare del tutto condivisibile.
Va premesso che, come correttamente si afferma in alcune delle sentenze adesive all’orientamento maggioritario, la natura plurioffensiva del reato in esame non vale a risolvere il problema dandosi casi di reati certamente plurioffensivi (per es. la strage, il falso in bilancio ecc.) che restano ipotesi di reato unico anche se le persone offese sono più d’una. Parimenti non sembra che il problema possa essere risolto in base alla formulazione letterale dell’art. 570 cod. pen. cpv. n. 2 sul rilievo che la norma non considererebbe singolarmente le posizioni degli individui; argomento ambivalente perché la formulazione letterale della norma potrebbe giustificare anche l’opposta soluzione fondata sulla circostanza che la norma individua gli aventi diritto ai mezzi di sussistenza – la cui mancata somministrazione è penalmente sanzionata - ma non fa riferimento, a differenza del comma 1°, a condotte contrarie “all’ordine e alla morale delle famiglie”.
E’ condivisibile invece la ricostruzione del percorso storico giuridico riguardante la famiglia con la considerazione che l’impianto originario, ma tuttora vigente, del codice penale – che inserisce il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel titolo XI (delitti contro la famiglia) – era forse idoneo a legittimare una considerazione globale dell’ordine familiare tale da giustificare una tutela unitaria e indifferenziata senza che venissero in considerazione le specificità delle situazioni individuali dei singoli componenti.
Già in questa costruzione era difficile individuare una concezione della famiglia come formazione sociale esclusiva che in qualche modo ricomprende in sé anche i diritti dei suoi componenti. Tanto più, come è stato affermato nella sentenza 19 giugno 2002 n. 36070, Armeli, rv. 222666, che “il concetto di famiglia nel diritto penale non è esattamente delineato essendo controverso se in esso sia adottata una propria ed autonoma nozione ovvero se si debba far riferimento a quella recepita nel diritto civile, anch’essa peraltro non compiutamente formulata e quindi tale da richiedere di volta in volta le necessarie specificazioni per stabilire a quale nozione di famiglia ci si intenda riferire (legittima o illegittima, naturale o civilmente riconosciuta, etc.)”. Ma le norme della Costituzione (artt. 2, 29, 30 e 31) e le riforme legislative successivamente intervenute in tema di diritto di famiglia hanno sicuramente rafforzato anche la tutela dei singoli componenti>>.
La Suprema Corte, peraltro, individua il limite di quelle interpretazioni che ravvisano nella disposizione di cui all’art. 570 c.p. la previsione di condotte tra loro omogenee.
A parere delle Sezioni Unite, invece, le condotte previste nel primo comma e quelle previste nel secondo hanno una natura diversa.
<<Non sembra però corretta la premessa metodologica dalla quale prendono le mosse entrambi i contrastanti orientamenti che sembrano prender le mosse dal presupposto che la norma incriminatrice (l’intero art. 570) preveda condotte assimilabili in categorie omogenee. In realtà si tratta di una norma che fa riferimento ad un ventaglio di condotte di natura diversa che, fermo restando il fine di tutela della famiglia e dei rapporti di assistenza nell’ambito familiare, prende in considerazione condotte ed eventi di diversa natura per i quali ben possono individuarsi beni non omogenei ma parimenti tutelati. E per ciascuna di queste ipotesi ben possono darsi soluzioni diverse quanto al tema dell’unicità o pluralità di reati.
Per esemplificare: l’abbandono del domicilio domestico previsto dal 1° comma dell’art. 570 in esame costituisce un reato unico perché diretto a tutelare esclusivamente la convivenza familiare e non essendo ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (non si può abbandonare il domicilio domestico soltanto nei confronti di uno dei componenti della famiglia). Chi abbandona la famiglia sottraendosi agli obblighi di assistenza non la abbandona in relazione alle singole posizioni individuali; per questa ipotesi sarebbe dunque impossibile affermare una lesione per così dire “frazionata” dell’interesse protetto. E così chi si sottrae ai medesimi obblighi, serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, analogamente compromette quest’ordine indipendentemente da quanti e quali sono i componenti della famiglia.
In questi casi è dunque legittimo affermare che il bene protetto dei singoli si identifica con quello della famiglia intesa nella sua unità e che quindi il reato deve essere considerato unico indipendentemente da quanti siano i componenti del nucleo familiare. Del resto, come si fa ad abbandonare il domicilio domestico soltanto nei confronti di taluni di coloro che vi abitano>>?
Nella sentenza, inoltre, si sottolinea la circostanza che, a differenza del primo comma, il secondo comma della norma in questione, tutela il patrimonio del soggetto debole.
<< Ben diverso è il contesto in cui si collocano le ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 570 cod. pen. dirette a tutelare non un’astratta unità familiare o un ordine o una morale familiare dai contorni indistinti, ma ben precisi interessi economici quali la tutela del patrimonio del soggetto “debole” (n. 1) e la vera e propria sopravvivenza economica di questi soggetti (n. 2).
Non è possibile parlare di tutela indifferenziata per l’interesse patrimoniale o economico di singoli soggetti i quali, oltre tutto, possono trovarsi nelle più diverse situazioni. Questa tutela patrimoniale ed economica del singolo componente della famiglia ben poteva essere distinta da quella generica della famiglia già nell’impianto originario della norma; e non è possibile affermarla oggi che addirittura alcune posizioni (quelle del più debole, il minore) sono state distinte dalle altre che sono divenute perseguibili a querela>>.
Particolarmente interessante è l’individuazione del dato letterale che induce ad abbracciare l’orientamento minoritario.
<<In realtà v’è una considerazione dirimente che vale a risolvere ogni dubbio che possa legittimamente perdurare su questo problema. Come - nel caso previsto dal n. 1 del comma 2° dell’art. 570 cod. pen. - è possibile che l’agente malversi o dilapidi i beni di uno dei soggetti protetti e non degli altri, così, nel caso previsto dal n. 2, è possibile che l’adempimento degli obblighi di assistenza economica avvenga per uno o più degli aventi diritto e non per l’altro o per gli altri e questa considerazione vale, da sola, ad escludere l’unicità del reato.
Se si pone mente alla formulazione della norma nella logica del reato unico quando vi siano più aventi diritto sarebbe addirittura esclusa – nel caso di adempimento solo a favore di taluno degli aventi diritto - la tipicità della condotta perché l’adempimento soggettivamente frazionato non è descritto nella condotta prevista dalla norma incriminatrice. E va precisato che, in adesione al principio affermato, ove più siano le omissioni (per es. nel caso in cui l’agente fosse tenuto a separati versamenti) deve ritenersi, sia pure con identiche conseguenze sul trattamento sanzionatorio, l’esistenza del reato continuato di cui al primo cpv. dell’art. 81 in esame e non il concorso formale>>.
Sulla base di tali presupposti, le Sezioni Unite ritengono corretta la decisione dei giudici di merito.
<<E’ dunque corretta la soluzione dei giudici di merito che hanno ritenuto l’esistenza del concorso formale perché l’agente, con un’unica omissione, ha commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 comma 1° cod. pen.).
Questa soluzione non differisce peraltro da quella che la giurisprudenza di legittimità ha accolto in altri casi, in particolare per l’ipotesi analoga relativa al reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen. nel caso di più soggetti passivi della condotta (v. Cass., sez. VI, 21 gennaio 2003 n. 7781, Simonella, rv. 224048).
Deve dunque affermarsi che “configura una pluralità di reati l’omessa somministrazione di mezzi di sussistenza nell’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare”>>.
I rapporti tra le fattispecie criminose di abbandono del domicilio domestico e omessa prestazione dei mezzi di sussistenza: il caso deciso da Cassazione penale sez. VI, 17/01/2011, n. 3016.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (primo e secondo comma dell'art. 570 c.p.), non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità86.
Il caso oggetto della pronuncia in questione riguarda un uomo condannato dai giudici del merito per il reato di cui all'art. 570 c.p., in quanto lo stesso aveva tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia avendo abbandonato la moglie, con gravi ripercussioni sulla salute psicofisica della donna.
L’uomo ricorreva in Cassazione lamentando la nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza tra la contestazione mossagli con l'imputazione e i fatti di cui è stato ritenuto responsabile.
Infatti, egli era stato tratto in giudizio con l’accusa di "essersi sottratto ai suoi doveri di marito, non contribuendo in alcun modo al sostentamento economico della sua famiglia". Il ricorrente affermava che nonostante avesse pienamente dimostrato di aver invece contribuito in modo sufficiente per il periodo considerato il Tribunale lo aveva condannato per aver abbandonato il domicilio domestico, in tal modo rimproverandogli un fatto per il quale egli non si era difeso nè aveva potuto valutare la convenienza di accedere a riti alternativi quali il patteggiamento.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
Al riguardo si legge nella motivazione della sentenza de qua: <<benchè genericamente accomunate dalla finalità di protezione dei medesimi beni (e cioè gli obblighi essenziali derivanti dai vincoli familiari), le condotte previste dal primo comma e dal capoverso dell'art. 570 c.p. non si trovano in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma sono del tutto eterogenee nella loro storicità e nella loro considerazione sociale, così da richiedere, sul piano processuale, l'apprestamento di strategie difensive completamente diverse>>.
Da ciò ne discende che l'accusa dell'abbandono del tetto coniugale con sottrazione dagli obblighi di assistenza morale corrisponde a un fatto nuovo rispetto a quella di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza e, secondo la Corte, <<ne è riprova l'osservazione che il proscioglimento da quest'ultima ipotesi non esclude, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., l'esercizio dell'azione penale per la prima condotta e viceversa>>87
2.5. Natura del reato e termine per la presentazione della querela
Secondo la giurisprudenza, il termine per proporre la querela decorre, ai sensi dell'art. 124, comma 1, c.p., <<dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, per tale dovendosi intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in guisa che la persona offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione>>.
Con particolare riferimento alla fattispecie, prevista dall’art. 570, comma 2 n. 1, c.p., <<il termine per proporre querela prende a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia a constatare il persistente inadempimento del soggetto tenuto alla prestazione, quale indice univoco, in assenza della evidenziazione di cause di giustificazione, della violazione dell’obbligo di legge>>88.
Sull’argomento, merita di essere attenzionata la pronuncia della VI sezione della Cassazione penale, n. 22219/10, nella cui motivazione è stato, per l’appunto precisato come <<Nel reato di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza, che ha natura permanente, il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha piena contezza del persistente inadempimento della persona obbligata, quale indice univoco, in assenza di cause di giustificazione, della violazione dell'obbligo di legge>>.
Il caso oggetto della pronuncia riguarda un marito resosi colpevole di aver fatto mancare alla moglie i mezzi di sussistenza omettendo di versare l'assegno di mantenimento mensile di Euro 800, determinato in sede di separazione dei coniugi.
Il marito proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte territoriale, adducendo i seguenti motivi:
- violazione di legge in quanto la querela era stata tardivamente proposta solo in data 9 dicembre 2004 per assegni non versati sin dal mese di agosto 2004, come chiarito alla udienza dibattimentale del 3 marzo 2006. L'azione penale doveva quindi ritenersi improcedibile;
- violazione di legge e vizio di motivazione, considerato che lo stesso aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, come documentalmente comprovato (dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005).
Alla luce delle suesposte considerazioni, egli domandava che fosse ritenuto escluso l'elemento soggettivo del reato.
Il marito-imputato lamentava, altresì, che la Corte d'appello non aveva considerato la costante giurisprudenza della Cassazione secondo la quale il reato non è configurabile per il solo mancato pagamento dell'assegno fissato dal giudice civile e che, in ogni caso, non erano emerse prove sufficienti e convincenti sul conclamato stato di bisogno della moglie, peraltro di giovane età e pienamente abile al lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo del ricorso non fondato e conseguentemente ha ritenuto l'azione penale non improcedibile.
Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza: <<Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine per proporre la querela ha inizio dal giorno in cui la vittima ha piena contezza del fatto che costituisce reato soltanto dopo avere constatato il persistente inadempimento della persona obbligata, quale indice univoco, in assenza della evidenziazione di una qualunque causa di giustificazione, della violazione dell'obbligo di fornirle i necessari mezzi di sussistenza.
D'altra parte, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma 2, n. 2, ha natura permanente e, in quanto tale, è "flagrante" per tutto il "periodo consumativi" (art. 382 c.p.p., comma 2), con l'effetto che la querela, in costanza di flagranza, deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al corrispondente periodo pregresso (Su tali questioni v. in motivazione, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11556 del 2009)>>.
Invece, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso.
In particolare, dopo aver premesso che lo stato di bisogno non può ritenersi provato per il solo fatto che sia stato fissato dal giudice un assegno di mantenimento in sede di separazione dei coniugi, occorrendo la prova della mancanza di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del beneficiario, ha ritenuto che l'indagine svolta dalla Corte d'appello fosse carente sotto molteplici aspetti.
Ciò in quanto negli atti del procedimento non si rinviene <<una qualsiasi indagine sulle condizioni personali e patrimoniali della moglie dell'imputato e manca altresì qualsiasi accertamento in ordine alla capacità lavorativa della beneficiaria del mantenimento e delle ragioni per le quali, eventualmente, non presti alcuna attività che sia fonte di redditi, fermo restando che l'onere della prova dello stato di bisogno della signora spetta, ovviamente, alla pubblica accusa>>.
Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio.

Su Shop.Altalex è disponibile il master:
Diritto delle relazioni familiari 4 incontri, 20 ore in aula, Altalex Formazione3. La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e scioglimento del matrimonio
3.1. Il principio della riserva di codice e la nuova topografia del Codice penale
Il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018 ha introdotto nel codice penale all’art. 3-bis il principio della riserva di codice, secondo il quale le "Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".
Con l’introduzione di tale principio, il Legislatore delegato ha recepito l’indicazione contenuta all’art. 1, comma 85, lett. q) della legge 23 Giugno 2017, n. 103 (legge delega), di garantire, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie incriminatrici, aventi ad oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale e previste da disposizioni di legge in vigore, una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, di conseguenza, l’effettiva funzione rieducativa della pena89.
Peraltro, il decreto in questione:
- ha inciso in maniera significativa sul testo del codice penale, quasi ridisegnandone la topografia, sia della parte generale, sia della parte speciale;
- ha attuato l’abrogazione di moltissime fattispecie incriminatrici, collocate nella legislazione complementare e relative a materie del tutto diverse tra loro;
- ha trasferito all’interno del all’interno del codice penale molte figure di reato o circostanze previste da leggi speciali.
Ciò ha determinato, tra l’altro, l’introduzione del Capo I-bis all’interno del Ti tolo XII del Libro II del codice penale, intitolato ai “delitti contro la maternità”, e di una Sezione I- bis all’interno del Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”90.
Inoltre, attraverso il decreto è stato riassettato l’istituto molto controverso della confisca “allargata”, che è stato collocato di una norma di parte generale del codice91.
3.2. L’art. 570 bis c.p.
Nel novero della revisione sistematica del Codice penale, si inserisce l’art. 570 bis c.p.92, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La norma ricalca, anche se non alla lettera, le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 12-sexies della Legge n. 898/1970 e dall’art. 3 della Legge n. 54/2006, norme che, come anticipato, sono state espressamente abrogate dall’art. 7, lettera b) e d) del d. lgs. n. 21/2018. Invero, il Legislatore delegato, in attuazione della legge delega, ha avuto l’intenzione di trasferire le disposizioni, previste dalle leggi speciali, all’interno del Codice penale. Nella relazione ministeriale allo schema del decreto legislativo, infatti, si legge che l’art. 570 bis “assorbe le previsioni di cui all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dello scioglimento del matrimonio)”(..) “e di cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli)”. Tuttavia, il testo del nuovo art. 570 bis c.p. desta numerosi dubbi interpretativi che contrastano con l’intenzione espressa nella legge delega, soprattutto con riferimento all’effettiva coincidenza del suo ambito applicativo rispetto alle disposizione in esso trasfuse ed abrogate. Al fine di meglio comprendere le questioni interpretative poste con riferimento alla nuova norma, è opportuno esaminare brevemente le disposizioni abrogate ed in essa confluite.
3.2.1. L’art. 12-sexies della Legge 898/1970
L’art. 12-sexies della Legge 898/1970 statuiva che “Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale”.
La disposizione aveva il precipuo scopo di garantire una tutela penalistica nei riguardi del coniuge beneficiario dell’assegno, considerato che l'introduzione dell’istituto del divorzio aveva lasciato prive rilevanza penale tutte quelle situazioni in cui l'ex-coniuge divorziato non adempisse all'obbligo di pagamento dell'assegno, stabilito dal giudice. La mancanza di tutela per il coniuge divorziato aveva dato luogo ad un forte contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle Sezioni Unite, le quali accolsero l’orientamento secondo il quale lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili determina il venir meno della qualità di coniuge93 e, pertanto rende inapplicabile la norma di cui all’art. 570 c.p., ma costituisce solamente un illecito civile. Il vuoto di tutela fu colmato con la legge di riforma del divorzio (art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 74), la quale mediante l’introduzione dell’art. 12-sexies in questione, attribuì rilevanza penale al mancato pagamento dell'assegno stabilito dal giudice per il coniuge divorziato. La norma fu accolta con favore dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali ritennero quasi concordemente che la nuova disposizione introducesse un'autonoma fattispecie incriminatrice, rispetto all’art. 570 c.p., stante che il richiamo a quest’ultima norma era soltanto quoad poenam.
Con riferimento ai rapporti tra l’art. 12-sexies e l’art. 570 c.p. si sono poste diverse questioni interpretative.
In particolare, si è posta la questione della differenza di trattamento tra coniuge separato e coniuge divorziato, stanche che mentre nella prima ipotesi, era punibile solo nel caso in cui aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge cui la separazione non sia stata addebitata, nella seconda ipotesi veniva sanzionato il mero mancato pagamento dell’assegno divorzile. La questione arrivò davanti alla Corte Costituzionale, che la ritenne infondata, alla luce della circostanza che le situazione del 'separato' e del 'divorziato', dei quali l'uno è ancora, in certa misura, personalmente legato al coniuge, mentre l'altro ha riacquistato lo stato libero sono del tutto differenti94, sono del tutto differenti.
Con riferimento alla natura del reato ed alle differenze con l’art. 570 c.p., la Corte di Cassazione, con varie pronunce, ha ritenuto che il reato di cui all'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898,, si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex-coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto e senza necessità che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno95. In buona sostanza si trattava di un reato omissivo proprio, di carattere formale, potendo essere soggetto attivo esclusivamente chi sia tenuto alla prestazione dell'assegno di divorzio e consistendo la condotta nell'inadempimento dell'obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice.
L’altra questione di grande rilevanza interpretativa, in quanto è stata oggetto di forte contrasto, è quella relativa al generico rinvio, operato dall’art. 12-sexies in questione all’art. 570 c.p. relativamente alle sanzioni applicabili. In particolare, si è posto il problema di stabilire se il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art.12 sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21, legge 6 marzo 1987, n, 74, si deve intendere riferito alle pene previste dal comma primo oppure a quelle indicate nel comma secondo della disposizione codicistica.
Il problema è stato affrontato e risolto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23866/2013, con la quale è stato statuito che “il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. effettuato dall'art. 12 sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica”.
Ovviamente, la norma in questione, con il richiamo all’art. 6 della legge n. 898/1970, apprestava tutela penale anche ai figli, non solo minorenni, ma anche maggiorenni non economicamente autosufficienti.
3.2.2. L’art. 3 della legge n. 54/2006 e la tutela del coniuge separato
La legge n. 54/2006 intitolata "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", dopo aver sostituito all'art. 1 il testo dell'art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori), ha inserito alcune norme nuove ed, in particolare: l’art. 155 bis c.c. (affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento convidiso), l'art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli), l'art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), l'art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) e l’art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore).
La medesima legge, all'art. 3 ha dettato alcune "Disposizioni penali", prevedendo che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies".
Anche questa norma è stata abrogata dalla recente novella.
La disposizione faceva riferimento solo ai coniugi, ma il successivo art. 4 affermava che le disposizioni della legge si applicavano anche ai figli di genitori non coniugati.
La legge in questione fu accolta con grande favore, considerato che ha finalmente equiparato la posizione dei figli di fronte alla tutela che l'ordinamento appresta per il caso di omesso versamento (in tutto o in parte) dell'assegno di mantenimento stabilito a loro favore, senza mantenere più alcuna disparità di trattamento tra figli di genitori separati, divorziati e non coniugati.
Il valore innovativo della novella è stato individuato appunto nel riequilibrio della preesistente situazione, con attribuzione alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione verso i figli, un trattamento analogo rispetto alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di divorzio.
Con riferimento all’art. 3 della L. 54/2006, in giurisprudenza, si è posto il problema se in caso di violazione degli obblighi di natura economica, le sanzioni penali contenute nella disposizione in esame, potessero ritenersi applicabili ai casi di mancato mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro.
La risposta al quesito è stata negativa96.
Conseguentemente, l’unica tutela che spettava ai coniugi separati, durante la vigenza della norma, era solamente quella individuata dall'art. 570 c.p.
3.2.3. Le tutele apprestate dall’art. 570 bis c.p.
Dopo aver esaminato la situazione preesistente nel nostro Ordinamento alla novella del 2018, con riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica in caso di divorzio e separazione, addentriamoci nell’analisi dell’art. 570 bis c.p. cercando di analizzare le questioni che si sono poste all’indomani dall’entrata in vigore della norma.
La prima domanda che è opportuno porsi è: Cos’è cambiato rispetto al passato?
In primo luogo, va rilevato come, in virtù dell’art. 570 bis c.p., oggi anche il coniuge separato è tutelato penalmente, nel caso di omesso versamento dell’assegno nei suoi confronti.
Come sopra anticipato, infatti, l’ipotesi de qua non era prevista come reato in quanto l’art. 570 fa riferimento al coniuge non separato e l’art. 3 della Legge 54/2006 non contemplava la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato.
In secondo luogo, la norma ha recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente in relazione all’art 12-sexies L. 898/1970 e, di conseguenza, la sanzione penale è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno. Infatti, adesso la sanzione penale è conseguente all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno o meno dell’avente diritto.
Quindi, si potrebbe verificare che il soggetto attivo sia sottoposto a processo penale in caso di mancata corresponsione dell’assegno provvisoriamente stabilito con il provvedimento presidenziale (in caso di separazioni giudiziali)97 e che, nelle more della definizione del procedimento penale, l’ assegno di mantenimento venga rivisto o addirittura revocato dalla sentenza che definisce il giudizio di separazione.
Tale situazione potrebbe essere paradossale, in quanto i provvedimenti presidenziali dati in sede di separazione o divorzio hanno il carattere della temporaneità e dell’urgenza e, pertanto, nel corso del giudizio possono essere ribaltati.
Si pensi ad esempio al caso in cui un coniuge abbia proposto richiesta di addebito nei confronti nell’altro coniuge e sia stato onerato in fase Presidenziale dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Successivamente, nel corso del giudizio riesce a dimostrare che la separazione è addebitabile al coniuge titolare dell’assegno, il quale, in seguito alla pronuncia di addebito non ne avrà più diritto.
Nel frattempo, però, si è instaurato un procedimento penale ex art. 570 bis c.p.. La domanda che potrebbe porsi è: che fine tale il procedimento?
Il problema non è di poco conto. Da un lato, infatti, applicando il principio dell’irripetibilità delle somme dovute a titolo di mantenimento, si dovrebbe ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p. per tutto il periodo in cui l’assegno, in virtù del provvedimento presidenziale, era dovuto e non è stato versato; dall’altro, non va dimenticato che la domanda di addebito deve essere proposta, a pena di decadenza con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione e risposta e, di conseguenza prima dell’udienza presidenziale.
La questione è aperta, poiché ancora non vi sono pronunce al riguardo, ma chi scrive non esclude che possa considerarsi un argomento difensivo da utilizzare.
Inoltre, va evidenziato come l’ultima parte dell’art. 570 bis c.p. faccia riferimento in modo alquanto generica alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Anche qui sorge il dubbio: è suscettibile di sanzione penale il genitore che omette di contribuire alle spese straordinarie, così come statuito dal giudice civile? Oppure la norma riguarda solo il caso di omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento. Invero la genericità della locuzione, ad avviso di chi scrive, potrebbe dare ingresso nella fattispecie incriminatrice a tutti gli obblighi di natura economica che vengono imposti nella parte dispositiva del provvedimento dato in sede di separazione o nel procedimento per l’affidamento dei figli.
Un ulteriore problema che si pone con riferimento all’art.570-bis c.p. è quello relativo all’apparente limitazione della fattispecie penale ai soli casi di affido condiviso dei figli minori98.
La norma contempla la condotta illecita in relazione alla violazione degli “obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, e, di conseguenza, facendo ricorso ad un’interpretazione strettamente letterale si dovrebbe ritenere che, se l’inadempimento si inserisce in una separazione coniugale in cui non è stato disposto l’avviso condiviso, bensì quello esclusivo aduno dei coniugi, l’eventuale inadempimento delle obbligazioni civili non integrerebbe la nuova fattispecie incriminatrice.
Invero, limitazione analoga non era desumibile dal disposto dell’art. 3 legge n. 54 del 2006, norma che si limitava ad estendere l’applicabilità dell'articolo 12-sexies della l. n.898 del1970, in caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla separazione, senza prevedere riferimento alcuno all’affido condiviso od esclusivo.
Orbene, interpretando la disposizione alla luce degli artt. artt.337-ter e 337-quater c.c., che non distinguono relativamente alla spettanza e alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, si dovrebbe concludere che la nuova fattispecie incriminatrice sia applicabile in entrambe le ipotesi.
Ed ancora, si è posto il problema dell’applicabilità della novella alle nuove formazioni familiari.
Sul punto, può ritenersi che l’art. 570 bis c.p. possa applicarsi (come del resto è stato ritenuto con riferimento all’art. 570 c.p.) nel caso di unioni civili99, alla luce di quanto disposto all’art. 574-ter c.p., di cui si è già discusso con riferimento all’art. 570 c.p.100.
3.3.Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all’art. 570 bis c.p.
L’altra importante e forse più dibattuta differenza con l’assetto normativo precedente è la circostanza che l’art. 570-bis c.p. ha determinato un vulnus di tutela penale degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli di genitori non coniugati.
La disposizione, infatti, è stata enunciata come reato proprio, dato che il soggetto attivo è il coniuge. Conseguentemente, chi non riveste la qualifica soggettiva di “coniuge” non può esserne autore101.
La questione non è di poco conto, anche in considerazione della circostanza che il principio di tassatività e il divieto di analogia della legge penale, impediscono qualsivoglia interpretazione estensiva della norma.
Peraltro, la lacuna non può essere colmata con il ricorso all’art. 570, in quanto, come ampiamente evidenziato, tale norma richiede come presupposto la mancanza dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o al coniuge non separato per colpa.
Invero, la questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata.
In particolare, la Corte di Appello di Trento, ha evidenziato un eccesso di delega.
Infatti, la legge delega in virtù della quale è stato emanato il d.lgs n. 21/2018 prevedeva esclusivamente il riordino della materia, per una sua migliore comprensione dei precetti penali, anche allo scopo di dare effettività alla funzione rieducativa della pena. Il d.Lgs. 21/18, tuttavia, ha determinato una selezione tra le fattispecie incriminatrici esistenti, con abrogazione di una di esse102.
La Corte di Appello di Trento si è posto anche il problema delle conseguenze di
una pronuncia di incostituzionalità in malam partem.
Si legge testualmente nell’ordinanza di rimessione: “In tale contesto, per quanto riguarda il denunciato eccesso di delega, rileva la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale “il difetto di delega, se esistente, comporta un esercizio illegittimo da parte del Governo della funzione legislativa” e “l’abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe in contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante (cfr. Corte Cost. n. 5/2014)”.
Anche la Corte di Appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità Costituzionale con riferimento all’art. 570 c.p.. In particolare, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci “sulla legittimita' costituzionale dell'art.570-bis codice penale in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”103.
Secondo la Corte d’Appello di Milano, mentre per i figli minorenni residua la tutela di cui all’art. 570 c.p., per i figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio, il vuoto di tutela risulta assoluto104.
Peraltro, giustamente, viene rilevata l’impossibilità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della norma. Si legge testualmente nell’ordinanza di rimessione: “la formulazione dell'articolo in esame, con l'espresso riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del reato, non lascia spazio ad alcuna interpretazione strettamente estensiva in favore dei figli nati fuori dal matrimonio ma rischia di risolversi in una applicazione analogica in malam partem della disposizione penale, in violazione del principio di legalita'. Deve inoltre aggiungersi, in conclusione, che gli obblighi dei genitori discendono dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla l'art. 30 Cost. il quale, nel prevedere il dovere dei genitori di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, non consente certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di coloro che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento possa venir meno sol per il fatto che la rispettiva prole non sia nata da un rapporto di coniugio”.
A conclusione del suo ragionamento logico giuridico, la Corte di appello evidenzia come l’art. 30 Cost “imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va a tutto beneficio dei figli, indipendentemente dalla posizione dei genitori”.
Canone di eguaglianza che, purtroppo, non è stato rispettato con riferimento all'art. 570-bis c.p.
In attesa della decisione della Consulta la questione resta aperta.
Certamente, la svista operata dal Legislatore delegato è stata grossolana, ma le conseguenze non sono di poco conto, soprattutto alla luce di un’effettiva comparazione tra figli “legittimi” e figli “naturali”.
Allo stato della legislazione vigente, infatti, l’unica tutela penale che viene riconosciuta ai figli nati fuoti dal matrimonio, che siano beneficiati di un assegno di mantenimento in sede civile è quella apprestata dall’art. 388 c.p..
La norma statuisce, al primo e secondo comma, che “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro centotre a euro milletrentadue.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.
Va rilevato che la locuzione "l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora" è stata dall'art. 2 D. Lgs. 01/03/2018, n. 21.
Ovviamente, si tratta di una tutela diversa rispetto a quella prevista dall’art. 570 bis c.p., dato che la norma è applicabile al caso in cui il soggetto obbligato ponga in essere atti fraudolenti sui propri o gli altrui beni, al fine di eludere il provvedimento giudiziale, reso in sede civile.
Formule degli atti processuali rilevanti con riferimento all’argomento trattato
-
Atto di costituzione di parte civile
TRIBUNALE PENALE DI …………..
Atto di costituzione di parte civile
Il sig……………………., nato a ………………………….., il…………………..e residente in…………. , via Treviso, n……, persona offesa dal reato, nel procedimento penale n………. R.G.N.R., a carico di ………………., a mezzo dell’avv. ……………….del Foro di …………, con studio in Francofonte a via Giarrusso, 3, suo procuratore speciale e difensore di fiducia,
dichiara
di costituirsi parte civile nel procedimento n. …………….. R.G.N.R., nei confronti di ………………., nato a……………….., il……………..e residente in…………….., via ………….., n….., per i seguenti fatti-reato di cui al………………………del……………….a firma del Procuratore della Repubblica, dott. ……………………..:
-
in ordine al reato .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-
In ordine al reato ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Scopo della presente costituzione è collaborare all’accertamento della verità dei fatti e di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati al sig…………………., dai fatti reati commessi dall’imputato, la cui responsabilità rinviene dagli atti di indagine svolta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ……………. e dall’emissione e nei suoi confronti del ………………………………
Il danno si quantifica in euro…………………………….., o nella misura maggiore o minore ritenuta giusta dal Tribunale, e si chiede la condanna dell’imputato al pagamento di detta somma, o di quella meglio ravvisata dal Tribunale, oltre al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Allega:
Data e firma
Procura speciale e nomina di difensore di fiducia
Il sottoscritto ………………………………, nato a …………………………., il……………………………..e residente in…………., via ………., n…….., nella qualità di persona offesa dal reato, con il presente atto delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale n. ……………………..della Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………………, pendente avanti il Tribunale …………………… di………………., l’avv., del Foro di …………………e con studio in ……………….., via…………….., n………….. ùLa nomina viene conferita anche per gli ulteriori gradi del procedimento.
Conferisce al su nominato difensore procura speciale affinché in suo nome e vece si costituisca parte civile nel suddetto procedimento contro ……………………al fine di chiedere il risarcimento dei danni morali e materali causati dai reati. Autorizza il su nominato procuratore speciale a depositare la sopra trascritta dichiarazione di costituzione e gli conferisce ogni più ampia facoltà di legge, ivi quella di farsi sostituire, con promessa di rato e valido.
Data e firma
Vera ed autentica la superiore firma
Avv.
-
Memoria scritta della parte civile
Memoria scritta della parte civile
Nel Proc. n.
Il sottoscritto Avv. ………………………. del Foro di…………………., difensore di fiducia e procuratore speciale, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale contraddistinto dal n. pendente innanzi a Codesto Ufficio, rassegna le seguenti
Conclusioni
voglia l'Ill.mo GUP, affermata la penale responsabilità dell'imputato……………, condannare lo stesso alle pene di legge e per l'effetto, riconosciutolo responsabile dei danni subiti dalla parte civile, a risarcire quest'ultima del danno nella misura complessiva di Euro ……….. o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Voglia in ogni caso l'Ill.mo Tribunale condannare l'imputato al risarcimento del danno risultato di giustizia o in separato giudizio civile con assegnazione di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
Voglia infine e comunque dichiarare la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.
(Nel caso in cui la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
Poiché il Sig. ………………….., ha presentato, in data…………, istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ed è stato ammesso con decreto n. …………. R.Grat. Patr., voglia liquidare i compensi difensivi della costituita parte civile a carico dell’Erario come da separata istanza di liquidazione che si produce unitamente alla presente.
(Se non vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato, unitamente alle conclusioni va prodotta la nota spese).
-
Memoria ex art 415 bis c.p.p.
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di………
Memorie e richieste dell’indagato ex art. 415 bis c.p.- Deposito documenti nell’ambito del procedimento penale n. …………
*****
Nell’interesse del Sig………………, indagato nel procedimento penale n. ………., difeso di fiducia dall’avv. Elena Salemi del Foro di Siracusa, indagato:
del reato p. e p.
Si espone quanto segue:
Alla luce delle superiori considerazioni è necessario che vi sia un approfondimento delle indagini.
Per quanto sopra il Sig. ………. al mezzo del suo difensore chiede
di essere Ascoltato-interrogato, direttamente-Personalmente da parte del P.M. (Art. 415 Bis 3° co C.P.P.), con l’ausilio di Registrazione fonica, di cui già con la presente si chiede copia;
– il Prosieguo delle Indagini, atte ad “accertare fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle Indagini” (Art. 358 cpp);
Deposita:
Data e firma
-
Atto di opposizione all’archiviazione
TRIBUNALE DI ………
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Atto di opposizione all’archiviazione e richiesta di prosecuzione delle indagini
Proc. Penale n…………………………..
Il sottoscritto Avv, , difensore di fiducia, giusta nomina versata in atti e procuratore speciale, giusta procura speciale allegata al presente atto, di…………………….., persona offesa nell’ambito del procedimento n. …….............
a fronte della richiesta di archiviazione, presentata dal P.M. titolare delle indagini, Dott., in data e notificata a mezzo Pec al sottoscritto difensore in data……, propone formale richiesta di
Opposizione all’archiviazione
con richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari
(ex artt. 409 e 410 c.p.p.)
1) I dati che emergono dalle indagini
2) Le circostanze che non sono state approfondite dal PM.
CONCLUSIONI
Per quanto sopra, il sottoscritto avvocato, chiede la continuazione delle indagini preliminari, mediante la prosecuzione dell’attività suppletiva e nello specifico, in perfetta conformità alle disposizioni normative, chiede si voglia procedere ad acquisire i seguenti ulteriori elementi di prova omessi dal PM:
Data e firma
Scheda riepilogativa per singolo reato
| ART 570 C.P. competenza: Trib. Monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: si rinvia all’art. 282-bis c.p.p. procedibilità: a querela di parte, salvo nei casi previsti dal comma 3 |
| ART: 570 BIS C.P. competenza: Trib. Monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentire procedibilità: a querela di parte |
Bibliografia
-
Bartolucci Proietti – L. Ceccarelli – S. Masato, Guida all’art. 570 c.p.- dai procedimenti in materia di famiglia al processo penale.
-
Cenci, Dovere di mantenimento dei figli, obbligo degli alimenti e delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, in dir. Famiglia, 1997, 3.
-
Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale, Relazione tematica sull’introduzione dell’art.570-bis cod.pen- Rel. N. 32/18 di cui all’urlp https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9830-relazione-massimario-violazione-obblighi-assistenza-familiare-3.pdf
-
Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, (voce) Violazione, in Enciclopedia del diritto, Ed. Giuffré, 1993.
-
Gatta G.L., Unioni civili tra persone dello stesso sesso: Profili penalistici- Note a margine del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, Diritto penale contemporaneo di cui all’urlp https://www.penalecontemporaneo.it/d/5200-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-profili-penalistici
-
Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, Napoli, 1931, Introduzione.
-
Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Nuvolone e Pisapia (a cura di), VII, Torino 1984, 863.
-
Marani S. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza.
-
Nuvolone, Trent’anni di diritto e procedura penale, tomo II Padova, 1969, 779.
-
Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt II, Roma, 1929, 334.
-
Salemi E., Nota a Cassazione penale, sezione IV, sentenza 1-22 marzo 2016, n. 12283.
-
Saltelli e Romano Di Falco, commento teorico – pratico – del nuovo codice penale, IV Torino, 1956, 197.
_________________
1 L'art. 93, comma 1, lett. o), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha introdotto il riferimento alla responsabilità genitoriale in luogo di quello della potestà.
2 Relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, pt II, Roma, 1929, 334.
3 In tal senso, si veda Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare,(voce) Violazione, in Enciclopedia del diritto, Ed. Giuffrè, 1993.
4 Saltelli e Romano Di Falco, commento teorico – pratico – del nuovo codice penale, IV Torino, 1956, 197.
5 Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, Napoli, 1931, Introduzione.
6 Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, cit..
7 Nuvolone, Trent’anni di diritto e procedura penale, tomo II Padova, 1969, 779.
8 Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, cit..
9 A. M. Bartolucci Proietti – L. Ceccarelli – S. Masato, Guida all’art. 570 c.p.- dai procedimenti in materia di famiglia al processo penale.
10 A. M. Bartolucci Proietti – L. Ceccarelli – S. Masato, Guida all’art. 570 c.p.- dai procedimenti in materia di famiglia al processo penale, cit.
11 La L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha recepito l’evoluzione sociale della famiglia, dando ingresso nel nostro ordinamento alle Unioni Civili ed al riconoscimento delle famiglie di fatto. All’indomani della novella, tuttavia e come sempre accade, si è posto il problema di adeguare la nuova realtà giuridico-sociale a delle norme penalistiche datate. Per una disamina dell’argomento, si veda Gian Luigi Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: Profili penalistici- Note a margine del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, Diritto penale contemporaneo di cui all’urlp https://www.penalecontemporaneo.it/d/5200-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-profili-penalistici.
12 Nella norma si legge testualmente: “Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
13 Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, cit..
14 Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, cit..
15 Al riguardo, infatti, l’art. 45 c.c. dispone che: <<Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore>>.
16 Per una visione completa sull’argomento, si tengano, altresì, presenti le seguenti disposizioni:
- art. 145 c.c., rubricato <<Intervento del giudice>>, il quale testualmente dispone: <<In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia>>.
- art. 41 disp. att. c.c.,norma la quale statuisce che <<I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica>>.
17Cassazione civile, sez. I, 03/10/2008, n. 24574.
In particolare,,nel caso oggetto della sentenza in questione, la Corte ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva statuito che le preminenti esigenze della famiglia, ai sensi dell'art. 144 c.c., dovevano essere ragionevolmente identificate con l'esigenza di salvaguardare l'attività professionale del marito, presumibilmente meglio retribuita e quindi di fatto più vantaggiosa per la famiglia medesima.
18 Anche se alla luce della sentenza di cui alla nota precedente, in alcuni casi si deve ancora fare i conti con anacronistici retaggi del passato!
19 Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, cit..
20 Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 2009, n. 14981.
21 I giudici di legittimità, inoltre, hanno escluso che alcune circostanze addotte dall’imputata potessero essere interpretate nel senso opposto:
<<Né possono valere in contrario le circostanze relative:
- al limitato bagaglio portato con sé dalla donna, che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono;
- al suo rientro successivo a casa, dovuto essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia (e al quale seguì presto un nuovo allontanamento, questa volta senza la minore), per la situazione di convivenza ormai compromessa anche per la posizione di rigida chiusura e diffidenza assunta dal marito>>.
22 Cassazione penale, sezione VI, 12 febbraio 2008, n. 11327.
23 Cassazione penale, sezione VI, 5/09/2000, n. 9440
24 Cassazione penale, Sez. IV, n. 34562/2012. Nella sentenza viene evidenziato come il primo comma dell'art. 570 c.p. riconduce, anche lessicalmente, l'abbandono del domicilio domestico a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie, richiedendo però che la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale, sicché rende punibile non l'allontanamento in sé, ma quello privo di una giusta causa. Per approfondimenti, cfr. nota di Simone Marani e nota su Altalex Mese.
25 Cassazione penale, sezione VI, 14 luglio 1989.
26 Si legge nella motivazione della citata sentenza:<<nell’ambito delle lacunose indagini della pubblica accusa (nulla è dato sapere sul rapporto coniugale della parte civile e dell’imputata, né se vi siano figli della coppia o prossimi congiunti dei coniugi) i giudici di merito, neppure ponendosi un problema di più approfondita conoscenza (con gli strumenti di cui agli artt. 507 e 603 c.p.p.), si sono limitati ad osservare che l’imputata ebbe a lasciare la dimora familiare>>.
Solamente su siffatto esclusivo elemento è stato ravvisato il reato contestato alla moglie allontanatasi dalla casa coniugale <<giudicandosi appagante la verosimile inesistenza di cause di forza maggiore sottese a tale allontanamento domiciliare per la sola emersa presenza, ad oltre un anno di distanza dal fatto, dell’imputata a (…)per motivi di lavoro. Né, diversamente da quanto paiono supporre le due conformi decisioni di merito, può farsi carico all’imputato di offrire dimostrazione delle ragioni della propria scelta, essendo dovere del p.m. prima e del giudice poi l’accertamento completo degli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, della fattispecie criminosa>>.
27 Cassazione penale, sezione IV, 4 dicembre 1979.
28 Cassazione penale, sezione VI, 3 giugno 1977.
29 Cassazione penale, sezione VI, 19 marzo 1980.
30 Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Nuvolone e Pisapia (a cura di), VII, torino 1984, 863.
31 Fattispecie in cui la inosservanza degli obblighi giuridici indicati nell'art. 570 c.p. era posta a base della contestazione di omicidio ex art. 40 primo capoverso c.p., poiché si era fatta risalire la morte di un minorenne, affetto da morbo di Coolaj, alle mancate terapie emotrasfusionali, alle quali i genitori si erano opposti per motivi di fede religiosa.
32 Cassazione penale, sezione VI, 25 marzo 2004, n. 26037.
33 Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza 2 aprile 2012, n. 12306
34 Si legge, al riguardo, nella motivazione della sentenza:<< gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all'art. 570 c.p., comma 1 riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull'esercente la potestà, che vengono meno con l'acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell'obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi>>.
Conseguentemente, <<il riferimento testuale al mancato esercizio della potestà genitoriale (oggi responsabilità) contenuto nella disposizione incriminatrice, oltre che la specifica disposizione dettata dal comma 2 n. 2 con riferimento agli obblighi economici, che costituisce un autonomo titolo di reato, esclude che possa ritenersi in questa sede, sulla base dell'accertato omesso pagamento, il diverso reato contestato dal primo giudice, ed espressamente qualificato come circoscritto all'art. 570 c.p., comma 1 dal giudice d'appello, dovendo limitarsi la cognizione di questa Corte alla valutazione di sussistenza dell'unico reato il quale è intervenuta condanna>>.
35 Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.07.2007, n° 30151.
36 Invero, tale fattispecie è di scarsa rilevanza pratica.
37 Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, cit.; Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, cit..
38 La riforma del 1975 ha apportato delle modifiche importanti anche con riferimento ai beni del coniuge.
In particolare, la legge di riforma del diritto di famiglia ha abrogato l’ipotesi di amministrazione esclusiva da parte del marito, ha vietato la costituzione di beni dotali ed innovato la disciplina della comunione dei beni.
39 Al riguardo, l’art. 320 c.c. statuisce che: <<I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore>>.
Per una visione completa sull’argomento, si suggerisce, altresì, la consultazione degli artt. 321 e 322 c.c.
40 Cassazione penale, sez. VI, 27/03/2008, n. 22401.
41 La legge di riforma del diritto di famiglia non fa più menzione della separazione per colpa, ma ha introdotto l’ipotesi dell’eventuale separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.
42 Cassazione penale, sezione IV, sentenza 23.04.2016, n. 17691.
43 Cassazione penale, sezione VI, n. 2736/2009.
44 Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 8 Gennaio 2016, n. 535. Si legge nella parte motiva: “Ed invero, il reato previsto dall'art. 570, secondo comma n. 2, cod. pen. ha come presupposto necessario l'esistenza di un'obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile nel senso che l'inosservanza anche parziale di questo importi automaticamente l'insorgere del reato, di tal che, per configurare l'ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all'assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l'obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza”.
45 La rilevanza penale della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento verrà approfondita nel Cap. III.
In questa sede, si riporta un altro passo della motivazione della sentenza citata alla nota precedente: “Difatti, come questa Corte ha avuto modo anche di recente di ribadire, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Sez. 6, n. 159898 del 04/02/2014 - dep. 09/04/2014, S. Rv. 259895)”.
46 La giurisprudenza ha precisato che deve distinguersi tra le nozioni civilistiche di mantenimento ed alimenti e quella penalistica di mezzi di sussistenza. Sul punto si riporta la massima tratta da Cassazione penale, sezione VI, 13 febbraio 2007, n. 14103: <<In regime di separazione personale tra coniugi, stante la diversa natura dell'assegno di mantenimento, volto a conservare la situazione patrimoniale quale era in seno al matrimonio, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. Il provvedimento del giudice civile, infatti, non fa stato nel processo penale né in ordine alle condizioni economiche dell'obbligato né per quanto riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto, circostanze che devono essere entrambe accertate in concreto. Di conseguenza, la mancata corresponsione, specie ove parziale, dell'assegno di mantenimento non rende, per ciò solo, responsabile l'obbligato del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., mentre anche il completo adempimento dell'obbligo civile potrebbe lasciare spazio alla configurabilità del reato suddetto, dovendosi distinguere dalle nozioni civilistiche di "mantenimento" e di “alimenti" quella dei "mezzi di sussistenza", che si identifica in ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come il vitto, l'abitazione, i canoni per utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l'istruzione e il vestiario>>.
In particolare, per quanto concerne il diritto agli alimenti, si ricorda che, ai sensi degli artt. 433-438 c.c., tale diritto ed il corrispondente obbligo può sorgere dalla legge, da un contratto o da un testamento ed è previsto a favore di soggetti incapaci di procacciarsi il necessario per vivere e pone il relativo obbligo di prestazione a carico di persone legate ai primi da rapporti di coniugio, parentela o affinità. In particolare, nella nozione di alimenti rientra, in aggiunta a tutto ciò che costituisce «mezzi di sussistenza» anche ciò che è solamente utile o conforme alla condizione dell'alimentando e proporzionale alle sostanze dell'obbligato.
Invero, anche i soggetti ai quali non è accordata tutela penale possono essere destinatari di obblighi civilistici.
Il diritto al «mantenimento» o agli «alimenti» può, infatti, essere vantato, in sede civilistica, da soggetti cui l'art. 570 comma 2 c.p. non offre alcuna tutela penale.
Si tratta, ad esempio, dei figli maggiorenni, dei figli naturali, del coniuge separato per colpa, dei fratelli o del donante.
47 Infatti, mentre in sede civilistica il diritto al mantenimento è riconosciuto anche nei confronti del figlio trentenne, che continua a vivere in casa dei genitori, finché non trova un posto di lavoro, adeguato alle sue aspirazioni e ai suoi studi, l'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha, invece, un contenuto non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente più ristretto rispetto alle obbligazioni previste dalla legge civile. Sull’argomento, si segnala Cassazione civile, sezione I, sentenza 23.10.2007 n° 22255, nella cui massima si legge:<< Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni il giudice deve tener conto del fatto che questi sono impiegati e stipendiati, a nulla rilevando la sproporzione reddituale tra i coniugi e la permanenza della convivenza con la madre>>.
48 Tribunale Genova, sentenza 7 ottobre 2008, n. 3436.
49 Per la differente tutela riconosciuta ai figli maggiorenni, nati fuori dal matrimonio, si rinvia al Capitolo III.
50 In tal senso, si veda Pretura di Lecce, sentenza 5 aprile 1996.
51 La tesi sopra enunciata, per quanto suggestiva, non è stata esente da critiche. Sull’argomento, si rinvia a Cenci, Dovere di mantenimento dei figli, obbligo degli alimenti e delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, in dir. Famiglia, 1997, 3.
52 Cassazione penale, sezione VI, 26 marzo 2003, n. 26725.
53 Cassazione penale, sez. VI, sentenza 27.08.2009 n° 33492.
54 Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31.10.2007 n° 40341.
55 Cassazione penale, sezione I, 17 maggio 2004, n. 32508.
56 Cassazione penale, sezione VI, sentenza 28.09.2009 n° 38127.
57 Cassazione penale, sezione VI, sentenza 21.01.2009 n° 2736 .
58 Cassazione penale, sez. VI, 12/07/2011, n. 34111.
59 Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 31 maggio 2016, n.23010
60Cassazione penale, sez. VI, 10/05/2011, n. 27051
61Nella motivazione della sentenza in questione si legge testualmente:<<Questa Suprema Corte ha già affermato che l'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone la capacità economica dell'obbligato, con la conseguenza che assume rilevo, ai fini di sanzionarne penalmente l'inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all'indisponibilità, persistente, oggettiva ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le "esigenze minime di vita".
Orbene, la sentenza impugnata da per certo che l'imputato, sordomuto, percepisse il solo reddito pensionistico per invalidità di circa 3.150 Euro all'anno.
Peraltro, la stessa sentenza, pur definendo le sue entrate "modestissime" e le sue condizioni di incolpevole e persistente "disagio economico", è pervenuta alla conclusione erronea che tale situazione non lo esimesse dell'obbligo di versare per la figlia minore l'assegno di mantenimento di 150 Euro mensili, almeno in parte, qualificando addirittura come "pervicace" il suo comportamento omissivo.
Pertanto, essendo stata accertata - nella sede di merito - una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula perchè il fatto non sussiste>>.
62 Cassazione penale, sez. VI, 19/07/2011, n. 35607.
63 Si legge testualmente nella parte motiva della sentenza: in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, Rv. 248955). In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Cass. Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), di una mera flessione degli introiti economici o di difficoltà (Cass. Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto non operante la dedotta causa scriminante non avendo il ricorrente provato che le difficoltà dal medesimo addotte (stato detentivo, problemi economici e dichiarazione di fallimento dell’azienda) si siano tradotte in una vera e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad adempiere”.
64 Cassazione penale, sezione IV, sentenza 1-22 marzo 2016, n. 12283, pubblicata su www.altalex.com con nota di Elena Salemi.
65 Dello stesso avviso, Cassazione penale, Sezione VI, n. 1021/14, la quale ha statuito che Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui le sentenze di merito si sono puntualmente attenute, lo stato di bisogno della minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi (cfr da ultimo Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014 - dep. 23/12/2014, P.C in proc. S, Rv. 261871). 6.2. Ne è determinante al fine lo stato di disoccupazione rivendicato dalle difese dei ricorrenti ove tanto non costituisce la causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabiltà penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2.
66 Manzini, Trattato di diritto penale italiano, cit..
67 In tal senso, si veda Pretura di Cuneo, 17 agosto 1995.
68 Cassazione penale, sezione VI, 30 novembre 1995, n. 204493, inedita, riportata in Pellegrino, Omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza e violazione degli obblighi di assistenza familiare, in Giur. merito 1999, 3, 545
69 Sull’argomento, si veda Oggero, Verso una violazione colposa degli obblighi di assistenza?, in Dir. pen. proc., 1996, fasc. 4, 97 ss.
70 In tal senso, Cassazione penale, sentenza 4 marzo 1988.
71 Cassazione penale, sezione VI, 1 ottobre 2007, n. 37978.
72 Cassazione penale, sez. VI, 17/11/2009, n. 8688.
73 Cassazione Penale, sez. VI, 26.11.2014, n. 52393.
74 Cassazione Penale, sez VI, 12.11.2014, n. 51215.
75 Cassazione penale, Sez. I, 13 dicembre 1995, n. 667. La sentenza è citata da Cocco, Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione, in Resp. Civ. e Prev. 2011, 10, 1949B
76 Cassazione penale, sez. VI, 18/02/1989.
77 Cassazione penale, sez. I, n. 27117/2011.
78 In particolare, è stata ritenuta palese <<la giuridica inconsistenza dei rilievi critici espressi con i due ricorsi sulla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, con riferimento - per i due periodi temporali consecutivi considerati dalle due decisioni di secondo grado - alla pretesa mancata dimostrazione di un effettivo stato di bisogno del figlio minore del L. e, specularmente, alla incapacità economica dell'imputato nel far fronte alla obbligazione pecuniaria. I motivi di ricorso avverso le due sentenze di appello, privi di specificità (ricalcano ragioni di gravame vagliate e puntualmente disattese dai giudici di merito) e per più versi non consentiti (critiche in prevalenza fattuali), sono palesemente infondati e destituiscono di pregio i rilievi sulla carenza e illogicità dei percorsi decisori confermativi della colpevolezza dell'imputato.
Le deduzioni delle due sentenze di appello, aderenti alle risultanze probatorie emerse nelle istruttorie dibattimentali di primo grado, sono corrette e lineari in rapporto ad entrambi i ridetti temi di censura enunciati dal ricorrente>>
79 Il Tribunale di Roma, infatti, non ha ritenuto sufficiente per lo scopo risarcitorio la deduzione che il genitore inadempiente fosse o fosse stato un dirigente della p.a. senza specificare e provare il tenore di vita del genitore predetto, le sue condizioni reddituali e patrimoniali, le sue condizioni sociali, e le opportunità od i traguardi cui la vittima avrebbe potuto aspirare ove il genitore avesse onorato i propri doveri parentali, nonché le concrete condizioni in cui essa è vissuta, potendo contare solo sul rapporto affettivo, economico, sociale e relazionale dell'altro genitore.
80 Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI, 27 marzo 2008, n. 22401.
81 Si legge al riguardo, nella motivazione della sentenza in epigrafe: <<Non a caso, prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale e della riforma del diritto di famiglia (salvo qualche isolata opinione in dottrina), si riteneva che potesse essere soggetto attivo del delitto anche la madre del minore la quale, all'epoca, aveva sì la "titolarità" ma non "l'esercizio della potestà", fin allora rigorosamente "paterna", tipicamente esercitata dal padre ex art. 3116 c.c., ed esercitata dalla madre soltanto dopo la morte del padre stesso e negli altri casi tassativamente stabiliti dalla legge>>.
La Corte precisa, altresì, che <<In tal senso soccorre tutta la giurisprudenza di questa sezione in punto di vicende della potestà e con la ribadita affermazione del principio secondo cui persino il radicale provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venir meno "i poteri" del genitore decaduto, ma non i "doveri" che non siano incompatibili con le ragioni che hanno dato causa al provvedimento stesso>>.
Dalle superiori considerazioni, discende che <<permanendo in capo al genitore decaduto, sia i doveri di natura economica che quelli di natura morale, il provvedimento ablativo della potestà non fa venir meno la permanenza del reato di cui all' art. 570, commi 1 e 2>>.
82 Cassazione penale, sezione VI, sentenza 12 novembre 2009 n° 43288. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un genitore, accusato del reato previsto dall'art. 570 c. 2 n. 2 c.p. - per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge ed ai figli minori.
Il Tribunale, in primo grado, lo riteneva colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Avverso la sentenza di primo grado, l’imputato proponeva appello, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in quanto egli non era affatto tenuto ad occuparsi delle figlie, considerato che era stato dichiarato decaduto dalla patria potestà con provvedimento del Tribunale.
La Corte d'appello rigettava l'appello proposto e confermava la decisione di primo grado.
Avverso siffatta pronuncia, il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento, tra gli altri, anche per erronea applicazione degli artt. 570 c.p. e 530 c. 2 c.p.p. ed illogicità della motivazione, in quanto l’imputato era stato dichiarato decaduto dalla patria potestà e, conseguentemente, non era più tenuto a occuparsi ed a provvedere alle figlie.
La Corte di Cassazione riteneva il ricorso inammissibile.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, <<la decadenza dalla potestà dei figli, che ai sensi dell'art. 330 c.c. il giudice civile pronuncia nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, è un provvedimento di natura sanzionatoria che, fondato sui medesimi presupposti, opera sul piano civilistico - con la sottrazione al genitore inadempiente dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonché dell'usufrutto legale sui beni stessi, finalizzato alla sua educazione e l'istruzione - parallelamente alle sanzioni previste dal codice penale che l'art. 570 c.p. riconduce testualmente a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori>>.
83 Cassazione penale, sezione VI, 14 gennaio 2004 n. 1251.
84 Sul punto si veda, Cassazione penale, sezione VI, 19 giugno 2002, n. 36070.
85 Cassazione penale, SS.UU., sentenza 26 febbraio 2008, n. 8413.
86 Cassazione penale, sez. VI, 17/01/2011, n. 3016.
87 Entrando nello specifico caso oggetto del procedimento, scrive la Corte; <<Nella specie l'aver ritenuto in sentenza che il P. era responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., per aver abbandonato la moglie con gravi ripercussioni sulla salute psico-fisica della donna, comporta dunque la mancata correlazione con la contestazione di "essersi sottratto ai suoi doveri di marito di C.M. non contribuendo in alcun modo al sostentamento economico della sua famiglia". Nè può ritenersi che la correlazione sia stata sostanzialmente rispettata rilevando, come fa la sentenza impugnata, che l'accusa di abbandono era chiaramente formulata nella querela presentata dalla donna: tale abbandono non era stato compreso nel decreto di rinvio a giudizio ed è questo l'unico atto al quale si deve far riferimento quando l'imputato resterebbe comunque soggetto ad un ulteriore esercizio dell'azione penale per la condotta non espressamente contestata.
3. La Corte d'Appello di Lecce pertanto avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 3 e a tanto si provvede nel dispositivo>>.
88 Si rinvia a Cassazione penale, sezione VI, 19 novembre 2008, n. 11556.
89 L’art. 1, comma 85, lett. q) della legge 23 Giugno 2017, n. 103 prevede l’ “attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.
90 Per un’analisi completa dell’argomento, si rinvia a Silvia Bernardi, Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa. A proposito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, di cui all’urlp https://www.penalecontemporaneo.it/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
91 L’art. 240 bis c.p., prevede che “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.
92 La norma è stata introdotta dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
93 Cassazione penale, SU, sentenza 26 Gennaio 1985, n. 3038
94 Corte cost., sent n. 472 del 1989
95 Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 5 Novembre 2008
96 Cassazione penale, sez. VI, 22/09/2011. Con riferimento ai rapporti tra l’art. 3 de quo e l’art. 570 c.p., la Suprema Corte ha ritenuto che la "violazione degli obblighi di natura economica" si riferisca in modo esclusivo al novellato art. 155 c.c. ed alle successive norme introdotte in materia, in quanto
I giudici di legittimità deducono inequivocabilmente la certezza di tale conclusione <<dalla lettura degli atti parlamentari della 14 legislatura, considerato che il testo dell'originario art. 3 in questione era il seguente: "1. la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570 cod. pen.": è quindi evidente, atteso l'incipit della originaria proposizione, che la portata e gli ambiti di applicazione della norma, nell'intenzione del legislatore e nel quadro delle riforme in concreto adottate, concernevano le sole obbligazioni di natura economica nei confronti dei soli figli>>.
Si legge ancora nella motivazione della citata sentenza: <<Nel corso dell'iter parlamentare, nella seduta 652 del 7 luglio 2005, risulta infatti essere stata approvata l'unica proposta emendativa (emendamento Magnolfi 3.351) che ha comportato l'intera sostituzione dell'iniziale formulazione dell'articolo stesso, il quale - come già detto - prevedeva il limite della esperibilità dell'azione ex art. 570 cod. pen. alla inadempienza, in danno dei figli, protratta per oltre "tre mensilità", con il testo ora vigente>>.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte conclude affermando che <<dalla riforma del 2006 è rimasta esclusa la sanzione di natura penale per il mancato adempimento degli obblighi verso il coniuge separato.
Nel silenzio della legge, invero, l'interpretazione che si impone è quella che individua gli obblighi di natura economica oggetto di tutela penale soltanto in quegli obblighi economici regolamentati dalla L. n. 54 del 2006, e cioè: gli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore a favore dei figli (minorenni e maggiorenni), escludendo quindi gli obblighi posti a carico di un coniuge a favore dell'altro, avuto riguardo al fatto che questi rapporti economici (lo si ripete) non sono stati oggetto di modifica da parte della L. n. 54 del 2006>>.
97 La norma fa riferimento ad ogni tipologia di assegno!!!
98 Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale Relazione tematica sull’introduzione dell’art.570-bis cod.pen- Rel. N. 32/18 di cui all’urlp https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9830-relazione-massimario-violazione-obblighi-assistenza-familiare-3.pdf
99 Scrive a tal proposito l’Ufficio del massimario, citato alla nota precedente: “L’unione civile viene regolamentata, in relazione ai reciprochi obblighi e diritti tra i contraenti, secondo il modello tipicamente previsto per il matrimonio, tant’è che si prevede che con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni; le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato; il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. A sugellare ulteriormente l’assimilazione tra matrimonio ed unione civile interviene la previsione contenuta dall’art.1, comma 20, l. n.76 del 2016 lì dove stabilisce che «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Anche il regime di scioglimento dell’unione civile ricalca quello previsto per il divorzio, tant’è che all’art.1, comma 25, si prevede che «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquiese 12-sexiesdella legge 1 dicembre 1970, n. 898».Nell’ottica della valutazione degli aspetti penalistici, è fin da ora rilevante sottolineare come il legislatore avesse dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti nascenti dalle unioni civili la previsione incriminatrice contenuta all’art.12-sexiesl.n.898 del 1970”.
100 Si ricorda, infatti, che il nuovo articolo 574 ter c.p. statuisce che:: a) agli effetti della legge penale e, pertanto, non con riguardo ai soli delitti contro la famiglia, «il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»; b) «quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso».
101 Tribunale di Treviso, sezione Penale, sentenza 8 maggio 2018, n. 554, la quale ha ritenuto che “Con l’introduzione dell’art. 570 bis c.p. è stato abrogato, ma non sostituito l’art. 3 della legge 54/2006. Invero, l’indicazione contenuta nell’art. 570 bis c.p., che fa espresso riferimento al “coniuge” che viola l’obbligo di mantenimento posto dal giudice civile in favore dei figli, non consente l’applicazione dell’articolo predetto rispetto a genitori non coniugati, le cui violazioni del dovere di assistenza familiare saranno però punibili ai sensi dell’art. 570 c.p.”
102 Si legge nell’ordinanza di rimessione, che “ Risulta, dunque, essere stata operata dal Legislatore delegato una abrogazione, non solo formale e funzionale alla realizzazione della riserva di codice, ma sostanziale di una parte della previgente previsione incriminatrice. E’ da escludersi che siffatto potere fosse attribuito dalla Legge delega, non solo in considerazione dell’inequivocabile mandato di (mero) trasferimento nell’unicità organica del codice penale di fattispecie criminose disseminate in leggi speciali, ma anche, come già osservato, in virtù della esplicitata finalità di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni in funzione dell’effettività della funzione rieducativa della pena in conformità ai principi costituzionali”
103 Nell’ordinanza di rimessione si legge testualmente: “Occorre sul punto effettuare un'ulteriore precisazione: infatti, per quanto concerne i figli minori nati fuori dal matrimonio, risulta, per le ragioni sopraesposte, che oggi essi non ricevono tutela a fronte del mero inadempimento delle obbligazioni patrimoniali stabilite dal Tribunale dei minori, ma a loro favore residua la sola tutela apprestata dall'art. 570, comma 2, n. 2,seguendo l'orientamento gia' esposto in Cassazione n. 2666/17, che, pero', ha presupposti applicativi ben piu' stringenti: l'illecito penale sussiste infatti solo a fronte dell'omessa erogazione dei mezzi di sussistenza, i quali si ritengono in ogni caso dovuti attesala presunzione dello stato di bisogno del minore, inabile a procurarsi il proprio sostentamento”.
104 Secondo la Corte di Appello, infatti: “gli stessi non trovano tutela ne' – come ampiamente detto - nel nuovo art. 570-bis codice penale, ne' nell'art. 570 codice penale, il quale tutela solo i figli minori e maggiorenni inabili al lavoro (vale a dire a quest'ultimo impossibilitati per cause oggettive)”.